La Fenice
10,00€
 Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
‘dopo la morte torno ad alzarmi’
Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
![]()
![]()
Presentazione La Fenice
A cura di Annamaria Carloni, con cui sono cresciuto e a cui sono molto legato affettuosamente e che mi ha spinto nella scrittura di questo racconto.
Felice è il nome più giusto per lui. Hanno scelto bene Gabriella e Luciano perché il nome imposto alla nascita, se ben augurante potrà esserci fedele alleato nella vita.
Se penso a Felice, che in qualche modo ho visto crescere e ho ben presente, prima da ragazzo poi come giovane padre, marito e imprenditore, ho sempre davanti agli occhi l’immagine di un uomo sereno, non turbato da sofferenze o preoccupazioni, generoso, aperto agli altri e capace di godere del privilegio di questo suo stato.
Ci eravamo salutati ad una conferenza stampa e poi improvvisamente è arrivata la notizia che non avremmo voluto ricevere: non solo Felice è positivo al Covid ma ricoverato al Cardarelli in terapia intensiva.
Uno shock per noi, per tutti gli amici e prima di tutti per i suoi familiari. Avevamo già perduto nella pandemia dei conoscenti e alcune persone molto care ma si trattava di persone che avevano vissuto una vita lunga e con patologie acclarate, ma ora si trattava di Felice.
Un giovane sano e pieno di vita, finito in coma, intubato in una terapia intensiva inaccessibile.
Dopo una prima telefonata a Luciano altre non ne avremmo potute più fare ai genitori, nostri carissimi amici. Non c’erano parole possibili, solo tanta angoscia appena mitigata dalla speranza e dalla fede.
In quelle settimane è stato Chicco, fratello amorevole e premuroso a tenere i contatti con gli amici ed informarci prima nelle lunghe settimane del coma e poi finalmente con la notizia della fuoriuscita dalla terapia intensiva. Si è trattato di un calvario che in qualche modo proseguiva nel long Covid e nel tempo ancora lungo della riabilitazione.
Ci siamo reincontrati dopo alcuni mesi. Seppure segnato nel corpo (mai visto prima di allora un Felice tanto magro) Felice era di nuovo tra noi, con tutto il carico di una esperienza indicibile, ma in presenza, con il suo carattere sempre positivo e il suo sorriso. Mi è parso giusto e possibile incoraggiarlo a scrivere. Non ero sicura che lo avrebbe fatto. Non è certamente facile, nè impresa per tutti scrivere un’autobiografia della sofferenza e men che meno quando si tratta di una malattia tanto grave e del coma.
Invece non solo Felice ha scritto, ma lo ha fatto proprio bene. Prendendo a prestito il titolo di un bel romanzo si potrebbe dire con “quella insostenibile leggerezza dell’essere” che tutto è meno che banale e superficiale.
Eccomi dunque ad onorare il mio impegno con Felice e scrivere una presentazione al suo racconto con la gioia per l’amico ritrovato, in salute, e con la consapevolezza che pubblicare questo racconto ha un valore in più.
La storia della pandemia da coronavirus attraverso il racconto di chi ha patito la malattia severa in prima persona non è solo riconducibile a mera testimonianza.
Lo dice molto bene Svetlana Alexievic (premio Nobel per la letteratura 2015), coloro che raccontano non sono soltanto dei testimoni bensì degli attori e creatori della storia.
Anche io penso, come lei, che più che una storia della pandemia quello di cui abbiamo oggi più bisogno è una storia delle persone nella pandemia.
Citare la Alexievic ci conduce direttamente all’oggi, alla guerra in corso. Lei infatti ha conquistato un posto di primo piano nella letteratura mondiale scrivendo un’altra storia delle guerre contemporanee.
Questa guerra contro l’Ucraina che ha invaso la nostra vita quotidiana e che mai avremmo pensato possibile, arriva dopo due anni di pandemia, ma il linguaggio mediatico non è cambiato.
Fin dall’inizio infatti con il trauma improvviso del coronavirus in mezzo a noi, il linguaggio bellico si è imposto quasi automaticamente.
Una guerra al Covid 19 a colpi di parole come: nemico da sconfiggere, trincea, assedio, fino a ritrovare gli eroi al fronte (medici e infermieri).
Quelle parole hanno alimentato un clima culturale e un contesto dove si è considerato normale non solo avere un commissario alla emergenza in tuta mimetica, ma soprattutto che si affermasse uno spirito emergenziale tale da favorire l’accettazione e indebolire lo spirito critico.
Nel primo lockdown sembrò normale stringersi in un moto di solidarietà corale dove paura e speranza si confondevano e risuonavano nel silenzio assoluto delle città i canti dai balconi e quella frase “andrà tutto bene” a caratteri cubitali sui davanzali come ad esorcizzare la paura con un atto di fede.
Soprattutto noi donne abbiamo creduto che la pandemia potesse essere una occasione per un cambiamento radicale degli stili di vita. Abbiamo parlato del valore della cura, della relazione tra le persone e della necessità di stabilire una nuova coesistenza con gli altri esseri viventi e non.
Le donne più di tutti hanno messo in gioco nella pandemia un potenziale di cambiamento sociale e culturale. Lo hanno fatto con il loro lavoro abituale per difendere la vita negli ospedali e nelle case e con il rifiuto del linguaggio bellico.
D’altra parte non esiste nessun nesso logico e non ha alcun senso mettere sullo stesso piano l’impegno contro la malattia che è fatto di cura appunto, di ricerca medica e scientifica, di relazioni umane, solidarietà, responsabilità di fronte alla morte con la logica del conflitto armato secondo la quale il nemico diventa il tuo prossimo.
Il linguaggio della cura per sè e per l’altra persona opponendosi a quello della guerra e dello scontro amico/nemico è sembrato prevalere in un primo momento ma poi non è stato così.
È stato soprattutto nella seconda ondata (quando anche Felice si è ammalato) di fronte alle difficoltà di procurare il vaccino che si è sviluppata una larga conflittualità con attacchi violenti soprattutto sui social, ma anche tra le persone, per esempio contro medici e infermieri quando i malati non restavano in vita. Si è rapidamente diffusa l’idea che si fosse perso tempo a costruire delle risposte, in particolare nella scuola, nei trasporti e che chi ci governava non fosse all’altezza.
Il ritorno alla normalità tanto desiderata sembrava impossibile mentre si aggravavano di molto le disuguaglianze e la sofferenza sociale. La povertà assoluta e relativa ha raggiunto cifre impressionanti e soprattutto la categoria dei lavoratori poveri, sconosciuta in passato. Mentre scrivo siamo alla fine dello stato di emergenza sanitaria e nei prossimi tempi si trarrà un bilancio più analitico di questi due anni a cominciare dalla triste contabilità dei morti per Covid 19. Si faranno confronti tra nazioni e regioni italiane Si ricorderà la pandemia di Spagnola nel secolo scorso, a cavallo tra le due guerre che fece 50.000.000 di morti nel mondo e 600. 000 in Italia.
Ci chiederemo come ci ha cambiato la pandemia e chi ha di più sofferto.
Certamente in prima linea e in primo piano tra i lavoratori massacrati dai turni e dalla mancanza di protezione ci sono medici, infermieri, tecnici e operatori della salute con centinaia di morti tra loro. Negli Ospedali, presi d’assalto in assenza di una medicina di territorio attrezzata e nelle RSA ci sono stati i tassi più alti di contagio.
Ora sappiamo che tutto sarebbe stato diverso, tanti lutti e sofferenze sarebbero stati evitati se avessimo avuto una medicina organizzata sul territorio con medici ed infermieri in numero e formazione adeguati, assistenza e terapie domiciliari, servizi di sostegno per persone fragili, servizi di prossimità.
Negli anni passati invece si è scelta la direzione opposta, anziché andare incontro alle persone e ai loro bisogni di salute si sono trascurati i presidi territoriali e le cure domiciliari per concentrare tutto nei grandi ospedali e proprio nella pandemia si è visto come questa scelta di concentramento abbia reso gli ospedali poco sicuri trasformandoli in luoghi ideali per il contagio.
In questo tempo inoltre sono sempre più in crescita gli episodi di violenza a cominciare da quelli all’interno delle case e in forme diverse si manifesta un malessere diffuso, anche psichico, e una rabbia sociale. È importante interrogarsi sulla radice di questa violenza e chiedersi che impatto abbiano avuto una modifica di così grande dimensione delle relazioni tra le persone come quella indotta dal Covid 19 con il confinamento unitamente all’impoverimento e alla paura.
Resta infine davvero sorprendente come dall’inizio della guerra contro l’Ucraina la comunicazione mediatica abbia interamente sostituito alla pandemia la guerra. Sono diversi gli attori che ne parlano ma il copione è il medesimo. La regola aurea continua ad essere quella della faziosità, quella che spinge a rintracciare innanzitutto il nemico secondo un rito primitivo e tribale così come vuole la logica della guerra, che prevarica e vince ancora ed è così forte da tenerci in ostaggio.
La testimonianza di Felice ci spinge invece ad uscire dall’inganno e dalla mistificazione dicendoci che tra aggredire o subire c’è invece un’altra possibilità semplicemente umana che è quella di lottare per vivere.
La forza esemplare della sua testimonianza è quella di chi ha vissuto il trauma e una grande sofferenza e ha saputo reagire senza lasciarsi cadere nella confusione, nella paura paralizzante, facendo i conti con le proprie fragilità e cercando sempre nelle giuste relazioni con gli altri le soluzioni per andare avanti.
Penso che testimoniare il trauma, le fragilità, il proprio bisogno di cura e di calore umano possa aiutare a dare risposte alla indifferenza, a quell’uso ignorante ed infantile della libertà senza responsabilità, a quella alterazione delle relazioni umane che intossica la nostra vita sociale.
Il sentimento della propria vulnerabilità come ci racconta Felice ci riconduce alla essenza dell’umano poiché tutti siamo sempre dentro una dinamica relazionale di cui per la propria parte ciascuno è responsabile.
Questo modo di sentire la responsabilità può rappresentare un antidoto ad un pensiero catastrofico e depressivo. E potrebbe spingere anche ad arginare quella ricerca primitiva di capri espiatori, quell’impulso arcaico a schierarsi dentro la logica amico/nemico che è vera e propria malattia del momento attuale.
Felice con questo suo racconto ci ha fatto un dono di cui essere grati e ci consegna una prospettiva diversa dove ciò che è semplice e umano possa prevalere e avere la forza di una creazione originale.
07615




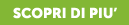






 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università
Lello –
Un inno alla vita. Le toccanti parole di Felice, il protagonista, che con la sua semplicità racconta rdi come ha affrontato questa avventura durante la sua degenza nel reparto COVID. Un viaggio onirico tra il mistero della vita e la meravigliosa voglia di vivere. Uno degli unici due pazienti a rimanere vivo tra i degenti del suo reparto. Un messaggio di un suo caro che gli viene in sogno, il rumore della chiusura dei sacchi che contenevano i corpi di chi non c’è l’ha fatta, la sua voglia di vivere… Un monito che val la pena ascoltare per questa tremenda storia che ha coinvolto, e ancora coinvolge tutti noi. Leggetelo!