Rapporto sullo stato sociale 2015 – 420/1
35,00€
 Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Autore: Felice Roberto Pizzuti
La grande recessione e il welfare state – Dipartimento di economia e diritto ‘Sapienza’, Università di Roma – Master di economia pubblica ‘Sapienza’, Università di Roma
Fuori Catalogo.
Consegna GRATIS in 2/3 giorni lavorativi.
Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
![]()
![]()
Esaurito
Edizione: 2015
Numero edizione: III
Pagine: 480
ISBN: 9788891406637
Codice: 420/1
Formato: 17 x 24
Abstract
Giunto alla sua undicesima edizione, il “Rapporto sullo Stato Sociale” costituisce un appuntamento stabile dedicato alle problematiche strutturali e congiunturali del welfare state nel contesto economico-sociale complessivo.
Sostenuto dal Dipartimento di Economia e Diritto e dal Master di Economia Pubblica di ‘Sapienza’, Università di Roma, il Rapporto offre un contributo di informazione sistematica con un ricco corredo statistico, valutazioni approfondite e proposte concrete su temi centrali per lo sviluppo economico, sociale e civile.
Il testo di quest’anno analizza come tema generale i caratteri della “grande recessione” nella quale si trova specificamente l’Unione Europea a sette anni dall’esplosione della crisi globale; approfondisce le sue prospettive, le responsabilità delle politiche comunitarie messe in atto per superarla e la particolarità dei problemi che si presentano in Italia.
Il Rapporto esamina le modalità seguite nella costruzione dell’Unione Europea e nella rivisitazione del suo Modello Sociale; evidenzia le contraddizioni tra i suoi potenziali punti di forza e gli effetti negativi delle politiche seguite, tra gli obiettivi ambiziosi e i risultati costituiti da minori tassi di crescita, maggiore disoccupazione, aumenti della povertà e della disuguaglianza.
Vengono quindi studiate le problematiche dello stato sociale in Italia, anche in rapporto agli effetti esercitati dai vincoli comunitari e dalle politiche nazionali. In particolare, vengono analizzate le ultime riforme del mercato del lavoro, del complessivo sistema previdenziale, degli ammortizzatori sociali, dell’istruzione, del sistema sanitario e dell’assistenza.
Le analisi sono accompagnate da valutazioni e proposte che interagiscono con il dibattito economico, politico e sociale.
Oltre ad essere uno strumento di lavoro per studiosi e operatori del settore, il Rapporto – per la sua organizzazione espositiva – si rivolge a tutti coloro, anche non esperti, che su questi temi di grande attualità intendono farsi un’idea più chiara e meno convenzionale di quella che spesso viene offerta dal dibattito politico e giornalistico.
420/1
“
Profilo Autore
Felice Roberto Pizzuti è professore ordinario nella Facoltà di Economia di “Sapienza”, Università di Roma e direttore del Master in Economia Pubblica attivo presso il Dipartimento di Economia e Diritto. Insegna Politica Economica e Economia e Politica del Welfare State.
È autore di molti libri e articoli, scientifici e giornalistici, pubblicati in Italia e all’estero. Studia, in particolare, le problematiche dello stato sociale e le loro interconnessioni con la globalizzazione e con la crisi, con la costruzione dell’Unione europea e con l’economia italiana.
Indice
Nota del Curatore
Considerazioni di sintesi
Capitolo 1 - «La grande recessione»: le prospettive e le politiche economico-sociali, le specificità dell’Unione Europea e dell’Italia
1.1 Note introduttive sullo stato della crisi e le politiche per superarla
1.1.1 Introduzione; p.39 - 1.1.2 Bilanci pubblici e crescita negli anni Duemila; p. 42 - 1.1.3 Gli effetti perversi del consolidamento fiscale e la spesa sociale; p. 46 - 1.1.4 L’ipotesi della «stagnazione secolare»; p. 49 - 1.1.5 La crisi e le sue prospettive osservate dall’Europa; p. 54 - 1.1.6 La specificità della crisi italiana; p. 61 - 1.1.7 Le prospettive dell’Unione Europea; p. 63 - 1.1.8 La questione dei debiti pubblici; p. 67
1.2 L’inconsistenza del «consolidamento fiscale espansivo»: la revisione dei moltiplicatori fiscali
1.2.1 Introduzione; p. 70 - 1.2.2 Il mondo in cui viviamo oggi; p. 71 - 1.2.3 Il mito del consolidamento fiscale espansivo; p. 72 - 1.2.4 Un riesame del consolidamento fiscale espansivo; p. 73 - 1.2.5 L’inesistente soglia del 90% per il rapporto debito pubblico/PIL; p. 75 - 1.2.6 La revisione al rialzo dei moltiplicatori fiscali 2012-2013; p. 77 - 1.2.7 Ulteriori prove: Batini et al. 2012; p. 79 - 1.2.8 Le implicazioni di moltiplicatori fiscali più elevati; p. 81
1.3 Il consolidamento fiscale può stimolare la crescita riducendo il rischio di default e i tassi di interesse? Il caso della periferia dell’Eurozona
1.3.1 Introduzione; p. 87 - 1.3.2 Il canale del rischio e le implicazioni per la condotta fiscale; p. 88 - 1.3.3 Il meccanismo di trasmissione della politica fiscale nei modelli monetari di equilibrio generale; p. 90 - 1.3.4 Quanto è rilevante il canale del rischio?; p. 91 - 1.3.5 Il canale del rischio alla prova dei PIIGS; p. 93
1.4 La spesa sociale nella grande recessione
1.4.1 Introduzione; p. 99 - 1.4.2 Gli indicatori della crisi; p. 100 - 1.4.3 La spesa per la protezione sociale secondo EUROSTAT; p. 102 - 1.4.4 Un’interpretazione dell’evoluzione italiana; p. 105 - 1.4.5 La vulnerabilità dei sistemi pensionistici; p. 107 - 1.4.6 I sistemi sanitari; p. 109 - 1.4.7 Spesa sociale privata e spesa sociale pubblica secondo l’OCSE; p. 112 - 1.4.8 - Il sistema di protezione sociale negli Stati Uniti p. 114 - 1.4.9 Il sistema previdenziale del Regno Unito; p. 121 - 1.4.10 Conclusioni; p. 124
1.5 Esiste una tendenza alla stagnazione secolare?
1.5.1 Introduzione; p. 125 - 1.5.2 Definizione ed evidenza; p. 125 - 1.5.3 Le cause; p. 129 - 1.5.4 Quali politiche?; p. 131
1.6 Gli effetti controproducenti della via tedesca alla costruzione europea
1.6.1 Introduzione; p. 133 - 1.6.2 Produttività e costo del lavoro: da dove viene la competitività?; p. 138 - 1.6.3 Considerazioni conclusive; p. 146
1.7 Quale competitività per l’Europa?
1 1.7. Introduzione; p. 147 - 1.7.2. La capacità competitiva delle industrie europee; p. 150 - 1.7.3. Il cambiamento strutturale nell’Unione Europea; p. 157 - 1.7.4. La strategia di politica economica dell’Unione per contrastare crisi e polarizzazione; p. 160 - 1.7.5. Le proposte alternative per la politica industriale nell’Unione Europea; p. 163 - 1.7.6. Conclusioni; p. 164
1.8 Crisi e polarizzazione produttiva nei paesi della UE
1.8.1 Polarizzazione degli skill; p. 165 - 1.8.2 Lavoratori dipendenti e autonomi; p. 167 - 1.8.3 Manifattura e servizi; p. 168 - 1.8.4 Migliori e peggiori performance settoriali; p. 169 - 1.8.5 Il gap occupazionale di genere; p. 170 - 1.8.6 Qualifiche e salari; p. 170 - 1.8.7 Paesi; p. 172
1.9 Le specificità della crisi dell’economia italiana
1.9.1 Introduzione; p. 175 -1.9.2 Un ritorno al passato: l’inversione di marcia dell’economia italiana; p. 178 - 1.9.3 Uno sguardo al futuro: il prodotto potenziale; p. 182 - 1.9.4 I cambiamenti del mercato del lavoro hanno guidato l’accumulazione di capitale; p. 183 - 1.9.5 I semi del declino sono stati gettati prima della crisi; p. 188 -1.9.6 Conclusioni e opzioni per la politica economica; p. 192
1.10 Dalla rottura non governata della UE all’Europa federale: scenari e implicazioni per il benessere economico e sociale nel «Centro» e nella «Periferia» della UE
1.10.1 Introduzione; p. 194 - 1.10.2 Gli scenari demografici ed economici in maggior dettaglio; p. 196 - 1.10.3 Implicazioni per la spesa per welfare; p. 204 -1.10.4 Il benessere sociale nei diversi scenari; p. 207
Capitolo 2 - Lo Stato Sociale in Europa
2.1 La spesa sociale nei paesi dell’Unione Europea
2.1.1 I livelli e l’andamento della spesa; p. 211 - 2.1.2 La spesa sociale per funzioni: trasferimenti monetari e in natura, strumenti universali e means tested; p. 215 - 2.1.3 La spesa sociale netta: il peso del prelievo fiscale; p. 220 - 2.1.4 Le fonti di finanziamento della spesa sociale e il cuneo fiscale; p.221
2.2 Gli indicatori sociali comunitari
2.2.1 La Strategia EU2020 e la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale; p. 224 - 2.2.2 Povertà monetaria; p. 227 - 2.2.3 Deprivazione materiale; p. 235 - 2.2.4 Esclusione dal mercato del lavoro; p. 236
2.3 Le politiche sociali della UE nella Strategia Europa 2020
2.4 La crisi e la diseguaglianza economica in Europa: il ruolo dei mercati e della redistribuzione
2.4.1 Introduzione; p. 241 -2.4.2 La disuguaglianza nei redditi disponibili in Europa durante la crisi; p. 242 -2.4.3 La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza; p. 244 - 2.4.4 Disuguaglianze ed evoluzione dei mercati; p. 247 -2.4.5 Conclusioni; p. 250
2.5 Le spese per l’istruzione e i risultati: Italia ed Europa a confronto
2.5.1 Benefici pubblici e privati dell’istruzione; p. 251 - 2.5.2 Il finanziamento dell’istruzione; p. 253 - 2.5.3 La qualità dell’apprendimento; p. 258 - 2.5.4 Tassi di scolarizzazione e livelli d’istruzione; p. 264 - 2.5.5 Giovani e mercato del lavoro; p. 267 - 2.5.6 Conclusioni. Gli obiettivi della strategia ET2020; p. 270
2.6 Senza lavoro e senza reddito? Il welfare europeo e italiano di fronte alla crisi
2.6.1. Introduzione; p. 271 - 2.6.2. Le politiche di reddito minimo in Europa: un quadro di sintesi; p. 272 - 2.6.3 Una lezione per l’Italia; p. 275 - 2.6.4 Politiche di reddito minimo e politiche del lavoro. Un raffronto con Germania e Francia; p. 277
2.7 I centri per l’impiego nei diversi regimi di transizione scuola-lavoro
2.7.1 Introduzione; p. 281 - 2.7.2 Il regime liberale: Il Regno Unito; p. 282 - 2.7.3 Il regime Europeo Continentale: La Germania; p. 285 - 2.7.4 Il regime scandinavo: la Svezia; p. 289 - 2.7.5 Il regime Europeo mediterraneo: l’Italia; p. 292 - 2.7.6 Conclusioni; p. 299
Capitolo 3 - Lo Stato Sociale in Italia
3.1 Evoluzione, composizione e finanziamento della spesa sociale
3.1.1 I dati ufficiali; p. 301 - 3.1.2 La spesa al netto delle voci non direttamente attribuibili a funzioni sociali; p. 305 - 3.1.3 La spesa per protezione sociale per funzioni e tipo riclassificate; p. 307 - 3.1.4 Il finanziamento della spesa sociale; p. 310
3.2 Criticità del Sistema Sanitario Nazionale: tra vincoli di bilancio, squilibri regionali e diritto alla salute equamente distribuito
3.2.1 Una breve introduzione al tema; p. 312 - 3.2.2 Per una concezione realistica e storicamente fondata del diritto alla salute; p. 313 - 3.2.3 Per una uguaglianza tendenziale, motivata e ragionevolmente stabile delle prestazioni sul territorio; p. 315 - 3.2.4 La progressiva divaricazione regionale dei LEA: una prospettiva da arrestare; p. 317 - 3.2.5 Lo stato di «salute» dei LEA e le differenze tra le regioni p. 319 - 3.2.6 Conclusioni; p. 330
3.3 Jobs Act e ammortizzatori sociali: riferimenti normativi, aspetti finanziari e valutazioni economiche
3.3.1 Il Jobs Act: sintesi dei riferimenti normativi; p. 331 - 3.3.2 L’evoluzione della spesa e dei beneficiari degli ammortizzatori sociali; p. 337 - 3.3.3 Il falso mito della rigidità del mercato del lavoro italiano; p. 341
3.4La recente evoluzione normativa del mercato del lavoro e della sicurezza sociale
3.4.1 Introduzione; p. 351 - 3.4.2 I cambiamenti introdotti dalla legge Biagi al mercato del lavoro; p. 352 - 3.4.3 Le modifiche del governo Monti all’articolo 18 e alla sicurezza sociale; p. 353 - 3.4.4 L’impostazione di riforma del governo Renzi; p. 356 - 3.4.5 L’eliminazione dell’articolo 18; p. 357 - 3.4.6 Il rilancio della precarietà; p. 359 - 3.4.7 La flexicurity del Governo Renzi; p. 365
3.5 La riforma dell’ISEE
3.6 Le politiche per l’istruzione dopo la riforma Gelmini-Tremonti e fino al Governo Renzi
3.6.1 Introduzione; p. 375 - 3.6.2 Il reclutamento degli insegnanti; p. 376 - 3.6.3 La valutazione degli insegnanti; p. 382 - 3.6.4 La valutazione delle scuole; p. 386 - 3.6.5 L’apprendimento permanente e il repertorio delle qualificazioni; p. 388 - 3.6.6 Conclusioni; p.391
Capitolo 4 - Il sistema previdenziale italiano
4.1 Il sistema pubblico a ripartizione
4.1.1 L’andamento del rapporto spesa/PIL; p. 393 - 4.1.2 Prestazioni e entrate contributive; p. 395 - 4.1.3 La struttura della spesa pensionistica; p. 396
4.2 La previdenza complementare
4.2.1 Aspetti normativi in Italia; p. 402 - 4.2.2 Principali aspetti quantitativi; p. 404 - 4.2.3 Rendimenti e costi amministrativi; p. 412
4.3 Previsione a lungo termine della spesa previdenziale
4.3.1 Le ipotesi di base; p. 417 - 4.3.2 L’evoluzione futura delle pensioni erogate e in essere; p. 420 - 4.3.3 L’evoluzione futura della spesa pensionistica; p. 423
4.4 L’adeguatezza delle future pensioni contributive: scenari di simulazione
4.5 Le criticità della proposta di ricalcolo contributivo delle attuali pensioni
4.6 Indicazioni per un riassetto del sistema pensionistico
4.6.1 Le politiche previdenziali prevalenti nell’ultimo ventennio; p. 441 - 4.6.2 Indicazioni per un riassetto del nostro sistema pensionistico; p. 448
4.7 I fondi pensioni e lo sviluppo dell’economia italiana
4.7.1 Due tipologie d’impiego delle risorse dei fondi pensioni per favorire lo sviluppo economico-sociale del Paese; p. 452 - 4.7.2 Effetti macroeconomici delle due tipologie d’impiego delle risorse dei fondi pensione; p. 455
Appendice statistica
Bibliografia
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Rapporto sullo stato sociale 2015 – 420/1” Annulla risposta


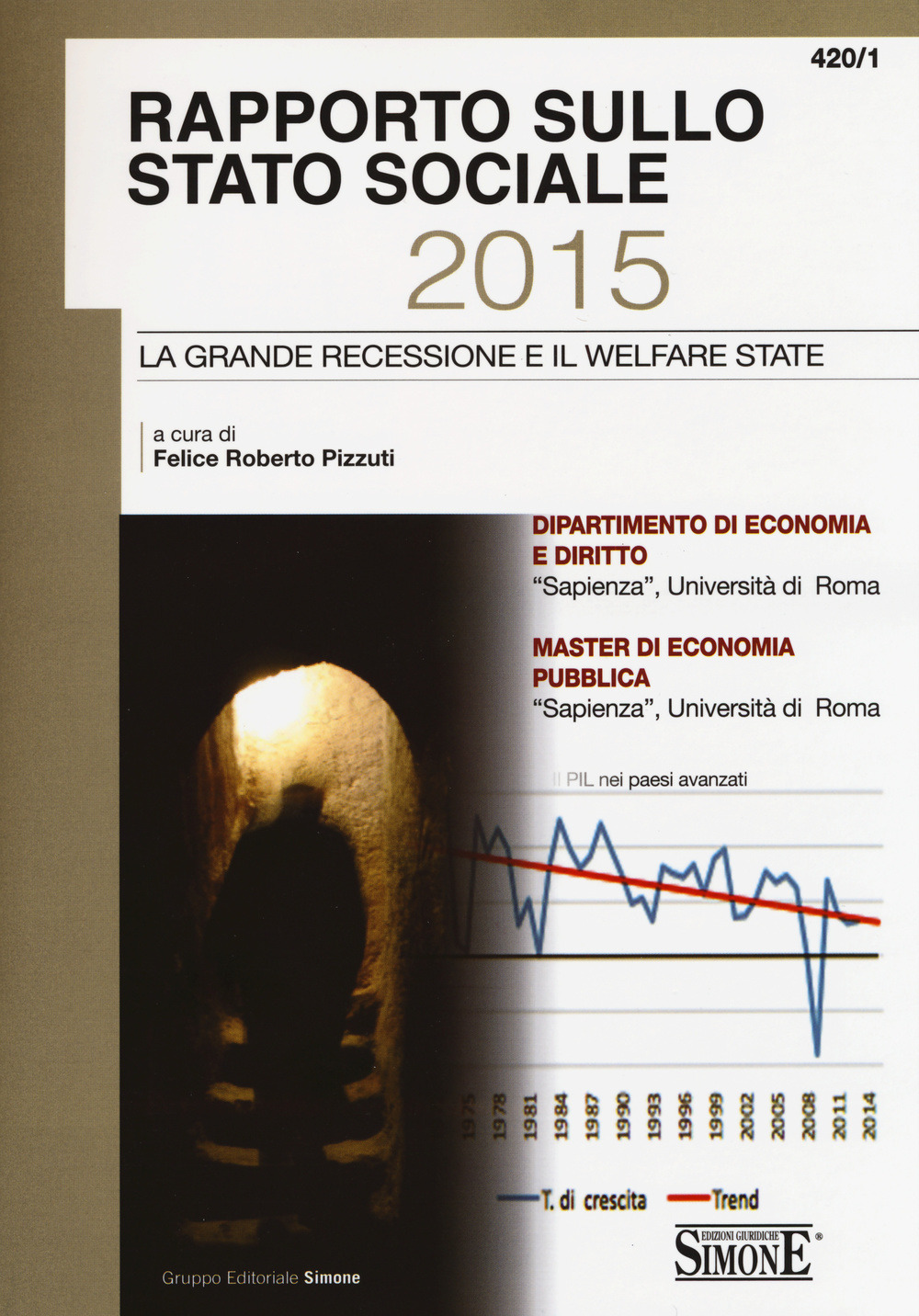






 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università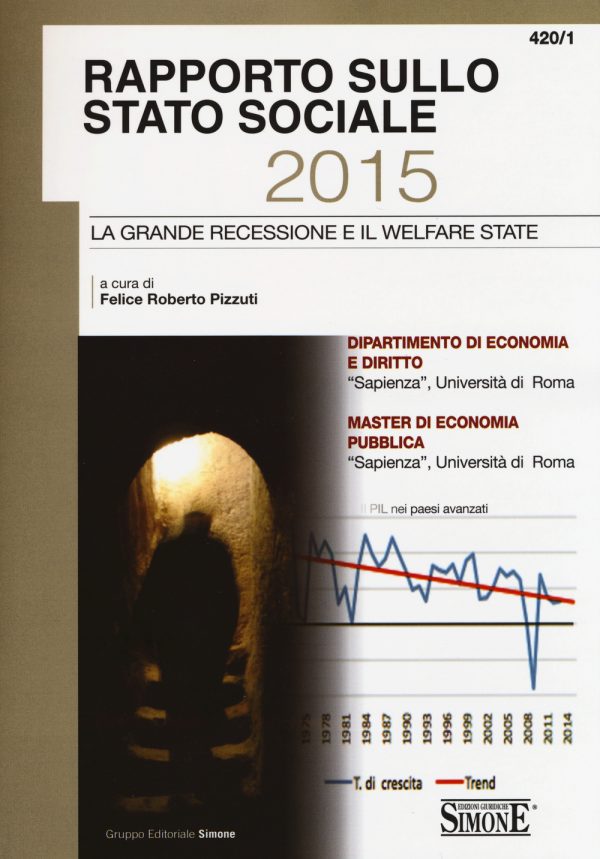
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.