Il Concordato Preventivo e gli Accordi di Ristrutturazione – L12/B
36,00€
 Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Autore: Enzo Sollini
Allegato al volume: – Software per la determinazione dei compensi del Commissario Giudiziale e del Liquidatore
Consegna GRATIS in 2/3 giorni lavorativi.
Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
![]()
![]()
Edizione: 2013
Numero edizione: III
Pagine: 384
ISBN: 9788891400284
Codice: L12/B
Formato: 17 x 24
Abstract
Secondo il legislatore del 1942, il concordato preventivo, considerato una «procedura minore» rispetto a quella di fallimento, era riservato agli imprenditori commerciali sfortunati ma onesti che si trovavano in stato d’insolvenza. In tale situazione, l’imprenditore «meritevole» poteva evitare il fallimento chiedendo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo e sottrarsi, così, al dissesto e alle ripercussioni derivanti dalla distruzione dell’azienda. La procedura premiava il debitore e garantiva i creditori. Questi ultimi, infatti, sapevano che al concordato preventivo poteva accedere soltanto l’imprenditore meritevole (che avesse, cioè, tenuto regolarmente la contabilità nei due anni precedenti, non avesse nel quinquennio anteriore fatto ricorso al concordato preventivo o dichiarato fallito, non fosse stato condannato per determinati reati) il quale doveva assicurare (attraverso serie garanzie reali o personali) il pagamento integrale dei creditori prelatizi e una percentuale non inferiore al 40% (zoccolo duro) a quelli chirografari — o colui che proponeva la cessione di tutti i suoi beni ai creditori e la valutazione di tali beni «facesse fondatamente ritenere» soddisfatte almeno le condizioni precedentemente riferite.
La procedura di concordato preventivo ha visto le prime modifiche profondamente innovative con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Con la miniriforma del 2005, e con le modifiche successivamente apportate, la procedura di concordato preventivo, regolata sempre all’interno del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 e rubricata «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» è stata rivoluzionata. Sono mutate la natura e la finalità della stessa, che non può più essere appellata «minore» poiché ha assunto, anche in relazione al contesto della situazione socio economica, il ruolo di procedura «principe». Con la nuova disciplina, l’imprenditore commerciale sopra soglia, secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 del R.d. 267/1942, che si trova in stato di crisi o d’insolvenza, può proporre ai suoi creditori la soddisfazione dei loro crediti (nelle diverse forme e modalità) secondo un piano la cui fattibilità deve essere attestata da un professionista indipendente nominato dal debitore e in possesso di determinati requisiti. Il debitore, che non è più soggetto al controllo di meritevolezza, può avanzare qualsiasi proposta, compresa quella di non pagare integralmente i creditori assisiti da cause di prelazione (ove ricorrano determinati presupposti), che dovranno essere verificati ed attestati con un’apposita relazione da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) l.f. È caduta, quindi, l’obbligatorietà di soddisfare integralmente i creditori privilegiati e, in misura non inferiore alla soglia del 40%, i creditori chirografari; ma v’è di più, i creditori possono essere suddivisi in classi «secondo posizione giuridica e interessi economici» riservando alle diverse classi trattamenti diversificati. Le modifiche introdotte man mano, da ultime quelle ex d.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013 (abrogazione della meritevolezza, abbassamento della percentuale necessaria per l’approvazione, eliminazione della misura minima dovuta ai creditori chirografari, possibilità di pagare in misura non integrale anche i creditori prelatizi, possibilità di ottenere finanziamenti in funzione e in esecuzione della procedura ecc.), sono state dettate dalla necessità di mantenere in vita l’azienda, sempre più considerata «bene comune» e fonte di ricchezza per la collettività e non come bene strettamente personale dell’imprenditore. La necessità di mantenere in vita l’azienda quale bene comune è sicuramente avvalorata dall’introduzione del concordato in bianco, che consente all’interessato di depositare un ricorso con allegata una scarna documentazione, riservandosi poi di presentare una proposta di concordato (o di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182bis l.f.) nel termine che gli sarà assegnato dal tribunale, usufruendo, così, di garanzie e benefici previsti in caso di deposito del ricorso contenente la proposta di concordato.
Il tribunale, nel concedere il termine (tra un minimo di 60 ad un massimo di 120 giorni), può anticipare la nomina del commissario giudiziale, che, ovviamente, ha soltanto la funzione di monitorare la situazione onde riferire al tribunale il compimento di atti non consentiti ex art. 173 l.f. In particolare, si ricorda che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese non si consolidano. Con le ripetute modifiche del Rd. 16 marzo 1942, n. 267, nel titolo III, ora rubricato «Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione», sono disciplinati istituti completamente nuovi: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis) e la transazione fiscale (art. 182ter). Il debitore, ai sensi dell’art. 182bis l.f., può ristrutturare la sua posizione debitoria attraverso un accordo con una parte dei creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento di tutti i debiti e chiederne l’omologazione al tribunale al fine di dare stabilità all’accordo stesso. I creditori estranei all’accordo hanno comunque diritto all’integrale pagamento del loro credito.
La transazione fiscale regolata dall’art. 182ter consente al debitore di proporre, in caso di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti, un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori (esclusa l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate), nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori.
L12/B
“
Aggiornamento Normativo
• D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
Indice
Parte prima: La riforma del concordato preventivo
1 L’Istituto del concordato nella vecchia normativa
1.1 Il premio per l’imprenditore sfortunato ma onesto
1.2 Le finalità del concordato preventivo
1.3 Le condizioni di ammissibilità
1.4 Gli effetti per il debitore e i creditori
1.5 Le conseguenze della non ammissione, non approvazione o non omologazione della proposta di concordato
1.6 Altre cause per la dichiarazione di fallimento dopo l’ammissione
1.7 Il decreto di ammissione
1.8 Il commissario giudiziale
1.9 La sentenza di omologazione
1.10 L’inadempimento della proposta omologata e la risoluzione
1.11 L’annullamento
2 Le caratteristiche del nuovo concordato preventivo
2.1 La necessità di una riforma generale
2.2 La miniriforma
2.3 Le caratteristiche salienti del nuovo concordato preventivo
2.4 Gli accordi di ristrutturazione
2.5 L’entrata in vigore della riforma del nuovo concordato preventivo
2.6 Le problematiche del periodo transitorio
2.7 Le difficoltà di raccordo con la vecchia normativa
2.8 Le modifiche normative e l’introduzione di nuovi istituti
2.9 La stabilità dei rapporti posti in essere prima del fallimento
Parte Seconda
Titolo III: Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo I: Dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo
3 I presupposti per l’ammissione alla procedura
3.1 Considerazioni generali
3.2 Lo stato di crisi
3.3 Nessuna condizione di ammissibilità
3.4 Il piano della proposta
3.5 La libertà di forma nella ristrutturazione dei debiti
3.6 Il trasferimento dei beni all’assuntore
3.7 La suddivisione dei creditori in classi
3.8 Il trattamento delle diverse classi di creditori
3.9 La valutazione in caso di soddisfazione parziale dei privilegiati
4 La domanda di concordato
4.1 Considerazioni generali
4.2 La presentazione della domanda
4.3 Il tribunale competente
4.4 La documentazione da allegare alla domanda, elencazione analitica
4.5 La relazione del professionista
4.6 Indipendenza e terzietà del professionista
4.7 La modifica della domanda
4.8 La revoca della domanda
4.9 La comunicazione al pubblico ministero
4.10 La domanda di concordato «in bianco»
4.11 Il termine per depositare la proposta e l’informativa periodica
4.12 Gli atti successivi al deposito della domanda in bianco
4.13 La nomina anticipata del commissario giudiziale
5 L’inammissibilità della proposta
5.1 Considerazioni generali
5.2 Le motivazioni dell’inammissibilità
5.3 Il decreto di inammissibilità
5.4 Le conseguenze dell’inammissibilità
5.5 Reclamo avverso la sentenza
6 L’ammissione al concordato
6.1 Considerazioni generali
6.2 Il controllo del tribunale e il decreto di ammissione
6.3 La nomina del commissario giudiziale
6.4 L’accettazione dell’incarico da parte del commissario giudiziale
6.5 La comunicazione della PEC al registro delle imprese
6.6 ll termine per la convocazione dei creditori
6.7 Il deposito della somma per le spese
6.8 Il compenso del commissario giudiziale in caso di mancato deposito
6.9 La cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione
6.10 Le istanze di fallimento pendenti
7 I decreti del giudice delegato
7.1 Considerazioni generali
7.2 Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato
7.3 L’impugnabilità del decreto del tribunale che decide sul reclamo
7.4 Le modifiche portate dalla riforma organica
8 Il Commissario giudiziale
8.1 Considerazioni generali
8.2 La figura del commissario giudiziale
8.3 La responsabilità del commissario giudiziale
8.4 Reclamo avverso gli atti del commissario giudiziale
8.5 La revoca e le dimissioni del commissario giudiziale
8.6 Il compenso del commissario giudiziale
9 La pubblicità del decreto
9.1 Considerazioni generali
9.2 La pubblicazione e l’iscrizione nel registro delle imprese
9.3 La trascrizione del decreto nei pubblici registri
9.4 Le novità introdotte dalla riforma organica
Capo II: Degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo
10 L’amministrazione dei beni durante la procedura
10.1 Considerazioni generali
10.2 La direzione del giudice delegato, abrogazione
10.3 La capacità processuale del debitore
10.4 La vigilanza del commissario giudiziale
10.5 Gli atti di straordinaria amministrazione
10.6 Atti senza autorizzazione del giudice delegato
10.7 I debiti anteriori all’ammissione
10.8 I crediti sorti successivamente all’ammissione alla procedura
11 Gli effetti della presentazione della proposta di concordato per i creditori
11.1 Considerazioni generali
11.2 Il divieto delle azioni esecutive
11.3 L’esperibilità delle azioni cognitive
11.4 Il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario
11.5 L’interruzione della prescrizione e della decadenza
11.6 L’inefficacia delle ipoteche iscritte nei tre mesi precedenti
12 Le norme del fallimento applicabili al concordato preventivo
12.1 Considerazioni generali
12.2 Gli effetti sui debiti pecuniari
12.3 La compensazione
12.4 I crediti infruttiferi
12.5 Le obbligazioni emesse
12.6 I crediti non pecuniari
12.7 La rendita perpetua e la rendita vitalizia
12.8 Le obbligazioni solidali
12.9 Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
12.10 Effetti sui rapporti giuridici pendenti
13 I contratti in corso di esecuzione
13.1 Considerazioni generali
13.2 La richiesta di scioglimento dal contratto
13.3 I contratti in corso non soggetti alla disciplina
13.4 L’indennizzo per il contraente in bonis
Capo III: Dei provvedimenti immediati
14 Le scritture contabili
14.1 Considerazioni generali
14.2 L’annotazione dell’ammissione alla procedura di concordato sulle scritture contabili
14.3 La disposizione e la conservazione delle scritture contabili
15 La convocazione dei creditori
15.1 Considerazioni generali
15.2 La verifica dell’elenco dei creditori
15.3 La convocazione dei creditori prima della PEC
15.4 L’introduzione della PEC nelle procedure concorsuali
15.5 La convocazione dei creditori tramite PEC
15.6 Il contenuto della comunicazione ex art. 171 l.f.
15.7 La convocazione in caso di numerosi creditori
15.8 Il rinvio della data di convocazione dei creditori su istanza del commissario giudiziale
15.9 La comunicazione agli obbligazionisti
16 Le operazioni e la relazione del commissario giudiziale
16.1 Considerazioni generali
16.2 La redazione dell’inventario
16.3 La relazione del commissario giudiziale
16.4 I termini per il deposito della relazione in cancelleria e la comunicazione ai creditori
17 La dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
17.1 Considerazioni generali
17.2 Le ipotesi per la dichiarazione di fallimento
17.3 Le previsioni di fallimento ai sensi del secondo comma
17.4 La consecuzione delle procedure
17.5 La procedura di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
17.6 La comunicazione ai creditori tramite PEC
Capo IV: Della deliberazione del concordato preventivo
18 L’adunanza dei creditori
18.1 Considerazioni generali
18.2 La partecipazione del debitore
18.3 La partecipazione dei creditori
18.4 I soggetti che partecipano all’udienza
19 La discussione della proposta di concordato
19.1 Considerazioni generali
19.2 La presenza del commissario giudiziale
19.3 Le ragioni dei creditori
19.4 Il diritto del debitore
20 L’ammissione provvisoria dei creditori contestati
20.1 Considerazioni generali
20.2 L’opposizione dei creditori esclusi
21 La maggioranza per l’approvazione del concordato
21.1 Considerazioni generali
21.2 Il diritto di voto
21.3 Il voto limitato ad una parte del credito
21.4 L’esclusione dal voto
21.5 L’approvazione del concordato
22 Le adesioni alla proposta di concordato
22.1 Considerazioni generali
22.2 Il verbale dell’udienza dei creditori
22.3 Le adesioni, da manifestazione espressa a silenzio assenso
Capo V
Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo
Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
23 La mancata approvazione del concordato
23.1 Considerazioni generali
23.2 Il non raggiungimento della maggioranza
23.3 Le conseguenze della non approvazione della proposta
23.4 La mutazione delle condizioni di fattibilità
24 L’approvazione del concordato e il giudizio di omologazione
24.1 Considerazioni generali
24.2 La fissazione dell’udienza di comparizione e l’avvio del giudizio di omologazione
24.3 La notifica ai creditori dissenzienti
24.4 La costituzione nel giudizio di omologazione
24.5 La costituzione del proponente
24.6 Il parere motivato del commissario giudiziale
24.7 L’intervento degli altri interessati
24.8 L’assunzione delle prove e l’omologazione
24.9 Gli adempimenti conseguenti al decreto di omologazione e l’impugnazione
24.10 Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili
24.11 La mancata omologazione
25 La chiusura della procedura
25.1 Considerazioni generali
25.2 Il termine massimo per chiudere la procedura di concordato
25.3 Le conseguenze dell’accorciamento del procedimento
25.4 La ragionevole durata delle procedure concorsuali
26 La cessione dei beni
26.1 Considerazioni generali
26.2 Il decreto di omologazione
26.3 Il liquidatore
26.4 Il comitato dei creditori
27 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
27.1 Considerazioni generali
27.2 Il tribunale competente
27.3 I presupposti dell’accesso alla procedura
27.4 L’accordo con i creditori
27.5 L’esperto e la sua relazione
27.6 Il deposito dell’accordo
27.7 Divieto di azioni per titoli e cause anteriori
27.8 Le opposizioni
27.9 L’omologazione
27.10 I benefici degli accordi di ristrutturazione omologati
27.11 Il reclamo contro il decreto del tribunale
28 La transazione fiscale
28.1 Considerazioni generali
28.2 La previsione della transazione fiscale
28.3 La proposta
28.4 La procedura
28.5 La comunicazione al commissario giudiziale
28.6 L’accettazione della transazione
28.7 La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione
28.8 La transazione fiscale fruibile anche dall’imprenditore agricolo
29 La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione
29.1 Considerazioni generali
29.2 La prededuzione dei crediti di finanziamento sorti in esecuzione della procedura
29.3 La prededuzione dei crediti di finanziamento sorti in funzione della procedura
29.4 La prededuzione limitata dei finanziamenti effettuati dai soci
30 La nuova finanza e i pagamenti di debiti anteriori
30.1 Considerazioni generali
30.2 La nuova finanza in prededuzione
30.3 Il pagamento di crediti anteriori nel concordato preventivo
30.4 Il pagamento dei creditori anteriori nell’accordo di ristrutturazione dei debiti
31 La riduzione di capitale per le società in crisi
31.1 Considerazioni generali
31.2 La sospensione degli effetti delle perdite sul capitale
31.3 La gestione della società ai soli fini conservativi
31.4 L’utilizzazione delle sopravvenienze a copertura delle perdite e ripianamento del capitale
32 L’appello contro il decreto che omologa il concordato
32.1 Considerazioni generali
32.2 La legittimazione a proporre reclamo
33 Gli effetti del concordato per i creditori
33.1 Considerazioni generali
33.2 Gli effetti dell’omologazione del concordato
33.3 I soci illimitatamente responsabili
Capo VI
Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo
34 L’esecuzione del concordato
34.1 Considerazioni generali
34.2 L’attività di sorveglianza
34.3 Il secondo comma
34.4 La cancellazione delle formalità pregiudizievoli
35 La risoluzione e l’annullamento del concordato
35.1 Considerazioni generali
35.2 La richiesta di risoluzione del concordato
35.3 La «scarsa importanza» dell’inadempienza
35.4 La risoluzione e l’annullamento
35.5 Il termine per esperire l’azione di risoluzione o di annullamento
35.6 La decisione del tribunale
35.7 Gli effetti della risoluzione
35.8 La garanzia prestata da terzi
36 Il concordato con continuità aziendale
36.1 Considerazioni generali
36.2 Le modalità di prosecuzione dell’attività
36.3 Il piano e l’attestazione del professionista
36.4 I contratti pubblici dopo l’ammissione alla procedura
36.5 La partecipazione a gare per l’assegnazione di contratti pubblici
36.6 La cessazione dell’attività
Parte Terza: Gli aspetti fiscali
37 Il contributo unificato
37.1 Il contributo unificato
37.2 Il pagamento del contributo unificato
38 L’imposta sul valore aggiunto
38.1 Aspetti generali
38.2 Le note di variazione IVA
39 L’imposta municipale propria (IMU)
39.1 Dall’imposta comunale sugli immobili all’imposta municipale propria, cenni
39.2 Il tributo nelle procedure concorsuali
39.3 La natura del tributo
39.4 Problematiche riguardanti l’IMU
40 Le imposte dirette, l’IRAP e le ritenute fiscali
40.1 Considerazioni generali
40.2 La irrilevanza della realizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze
40.3 Gli effetti per il creditore
40.4 La decadenza dal regime della trasparenza
40.5 L’imposta regionale sulle attività produttive
40.6 Le ritenute fiscali
41 L’imposta di registro
41.1 La tassazione (della sentenza di omologazione) prima della riforma
41.2 La tassazione del decreto di omologazione
42 Sanzioni per omessi versamenti a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo
42.1 Il divieto di pagamento dei debiti anteriori all’ammissione alla procedura
42.2 Le conseguenze del mancato pagamento dei debiti fiscali e contributivi
APPENDICE
D.M. 25-1-2012, n. 30 (G.U. 26-3-2012, n. 72). — Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo
R.D. 16-3-1942, n. 267. — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa
Bibliografia
Accedi alle risorse online
Clicca sul pulsante seguente per accedere alle risorse online.
COME ACCEDERE ALLE ESPANSIONI ONLINE: GUARDA IL VIDEO.
Area riservata
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Il Concordato Preventivo e gli Accordi di Ristrutturazione – L12/B” Annulla risposta


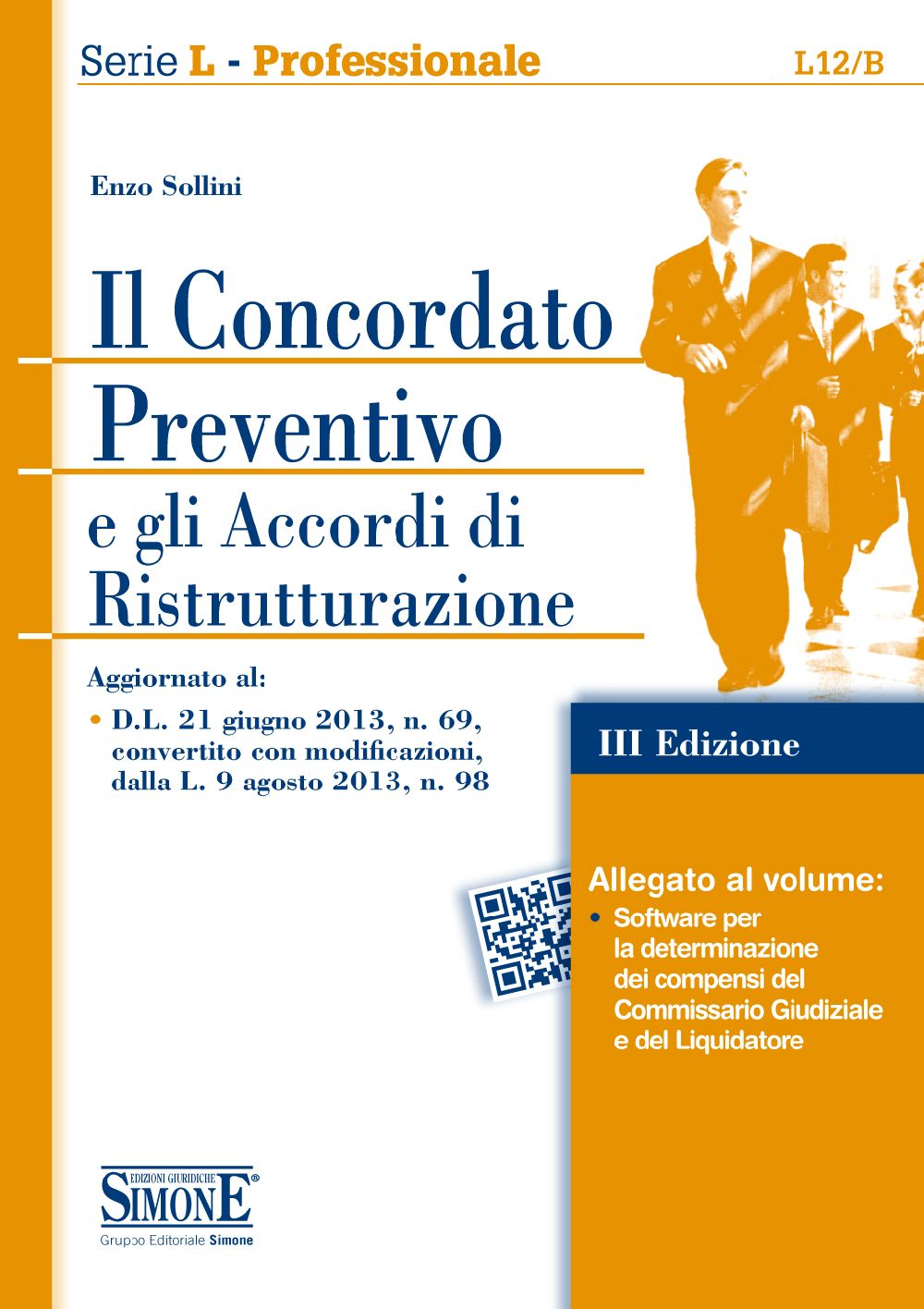






 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università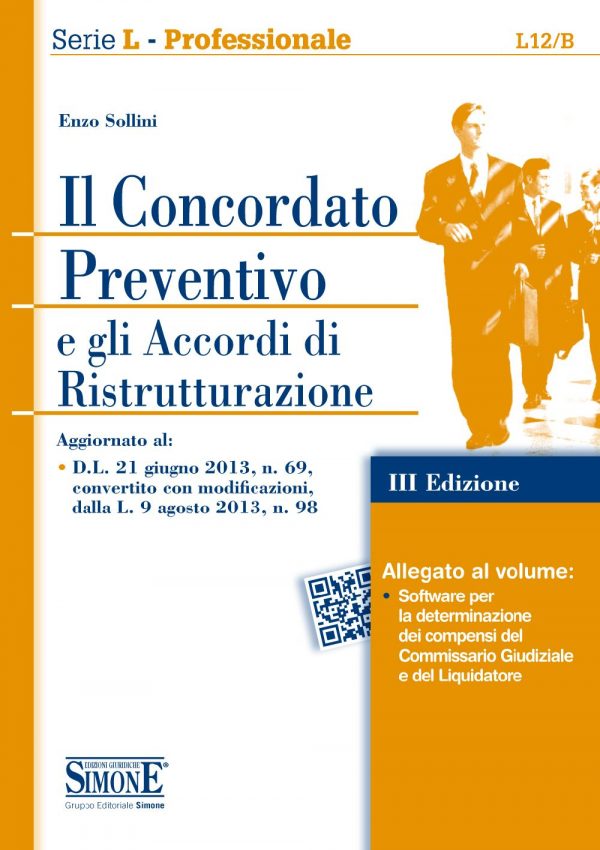
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.