Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
![]()
![]()
Manuale di Scienza delle Finanze
22,00€ Il prezzo originale era: 22,00€.20,90€Il prezzo attuale è: 20,90€.
 Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Avvisami
Esaurito
La Scienza delle Finanze studia le modalità attraverso le quali lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano le risorse necessarie a soddisfare i bisogni collettivi, valutando gli effetti dell’attività finanziaria pubblica sull’equilibrio economico generale e sul benessere dei cittadini.
Il volume analizza in modo chiaro i principi fondamentali della materia e si sviluppa in tre parti:
— la prima analizza le ragioni dell’intervento pubblico nell’economia secondo le principali teorie finanziarie. Dapprima fa riferimento all’evoluzione delle teorie economiche e dei sistemi economici, successivamente affronta il problema del fallimento del mercato;
— la seconda si sofferma sulle caratteristiche delle entrate e delle spese pubbliche nonché sulle conseguenze delle decisioni assunte in tale ambito sulla distribuzione del reddito e sull’equità sociale. Più specificamente, per ciò che concerne le entrate dello Stato, sono descritti i principali tipi di tributi, la teoria dell’incidenza delle imposte, le teorie sui criteri distributivi delle imposte e l’eccesso di pressione tributaria. Viene, quindi, analizzato il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale (sia dal punto di vista teorico sia sotto l’aspetto istituzionale). In relazione alle spese pubbliche, particolare attenzione è dedicata alla sicurezza sociale;
— la terza descrive le fasi di formazione del bilancio dello Stato anche alla luce dei vincoli economici derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Sono descritte, inoltre, le peculiarità e le finalità dei principali strumenti della programmazione economica, quali il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento del DEF, la legge di bilancio ecc.
Il manuale, inoltre, dedica ampio spazio ad argomenti di grande interesse e quanto mai attuali quali, ad esempio, la crescita del debito pubblico e la revisione della spesa pubblica, ed è arricchito da un test di autovalutazione, costituito da quesiti a risposta multipla su tutti gli argomenti trattati.
Il testo, dunque, per le caratteristiche descritte, rappresenta un valido supporto per coloro che devono sostenere esami universitari o partecipare a concorsi banditi da pubbliche amministrazioni.
12
Parte I
Le ragioni dell’intervento pubblico nell’economi a secondo le principali teorie fin anzi arie
Capitolo 1: Introduzione allo studio della scienza delle finanze
1. L’oggetto di studio della scienza delle finanze
2. La scienza delle finanze e il diritto finanziario
3. Le principali teorie sulla natura dell’intervento pubblico (rinvio)
Capitolo 2: Le teorie volontaristiche
1. Introduzione
2. Emil Sax e i bisogni collettivi
3. Lo «scambio volontario» di De Viti De Marco
4. Lo schema di Wicksell: il problema del free rider
5. Le critiche al modello volontaristico
Capitolo 3: Gli approcci politico-sociologici
1. Wagner e la crescita del settore pubblico
2. Il conflitto governanti-governati
3. Puviani e l’illusione finanziaria
4. La scuola marxista
Capitolo 4: La scuola delle scelte pubbliche
1. Il campo di indagine
2. Il principio dell’unanimità di Wicksell e il modello di Buchanan e Tullock
3. La votazione a maggioranza
3.1 Il paradosso della maggioranza
3.2 Il teorema dell’elettore mediano
4. Lo scambio dei voti (logrolling)
5. Il teorema dell’impossibilità di Arrow
6. Rappresentanza democratica: i politici, i burocrati e i gruppi di pressione
Capitolo 5: Keynes e la finanza congiunturale
1. La finanza del reddito nazionale
2. Il pensiero keynesiano
2.1 La moneta
2.2 Il ripudio della legge di Say
2.3 La rigidità dei salari
3. Il compito dello Stato in Keynes
4. L’attività della pubblica amministrazione e il moltiplicatore
5. Il finanziamento della spesa pubblica mediante imposte
6. Il teorema di Haavelmo
7. Le politiche di stabilizzazione
8. La programmazione economica
Capitolo 6: I limiti delle politiche fiscali
1. Premessa
2. Le critiche allo stop and go
3. I limiti degli stabilizzatori automatici
4. Il crowding out o spiazzamento
5. La critica monetarista
6. La curva di Phillips
Capitolo 7: L’economia del benessere
1. Introduzione
2. L’ottimo paretiano
3. Efficienza e benessere
4. I teoremi dell’economia del benessere
Capitolo 8: La redistribuzione del reddito: le funzioni del benessere sociale
1. La distribuzione del reddito
2. Le unità di osservazione: l’individuo e la famiglia
3. La misura della disuguaglianza: curva di Lorenz e indice di Gini
4. Concetto di povertà
5. Teorie sulla redistribuzione del reddito: utilitarismo
5.1 Funzioni del benessere sociale
5.2 Criterio del maximin
6. Incidenza della spesa pubblica sulla distribuzione del reddito
7. La «nuova economia del benessere»
7.1 Pigou
7.2 La compensazione potenziale
Capitolo 9: Il fallimento del mercato
1. Introduzione
2. L’assenza di un mercato di libera concorrenza
3. L’esistenza di rendimenti crescenti
4. Le esternalità
4.1 Regolamentazione delle esternalità
4.2 L’imposta pigouviana
4.3 Teorema di Coase
5. I beni pubblici
6. La carenza e l’asimmetria di informazioni
7. I merit goods o beni meritori
8. Le vicende del paretianesimo: il «marginal cost pricing»
9. Il second best
Capitolo 10: Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia
1. Il trade-off tra efficienza ed equità
2. I soggetti della finanza pubblica
3. Gli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia (rinvio)
4. Le caratteristiche dell’intervento pubblico nell’economia
5. Il bilancio dello Stato (rinvio)
Capitolo 11: L’analisi benefici-costi
1. Introduzione
2. L’analisi benefici-costi ABC
2.1 Il metodo del valore attuale
2.2 Il metodo del valore attuale relativo
2.3 Il metodo del tasso di rendimento interno
3. Gli effetti dei progetti pubblici
4. I prezzi ombra
5. Il tasso sociale di sconto
6. Beni non scambiabili sui mercati
7. Considerazioni conclusive
Parte II
L’attività finanziaria dello Stato: le entrate e le spese pubbliche
Capitolo 1: Le entrate pubbliche
1. Distinzioni in materia di entrate pubbliche
2. I beni pubblici
2.1 Distinzione dei beni pubblici
2.2 I beni demaniali
2.3 Classificazione e regime giuridico dei beni demaniali
2.4 I beni patrimoniali
2.5 I beni patrimoniali indisponibili
2.6 I beni patrimoniali disponibili
3. Le imprese pubbliche
3.1 Individuazione della categoria
3.2 Le cause della nascita delle pubbliche imprese
3.3 Forme di esercizio dell’impresa pubblica
3.4 La privatizzazione in Italia
4. Le entrate tributarie
5. Le entrate straordinarie
5.1 Alienazione di beni patrimoniali
5.2 Tesoro di guerra
5.3 Contribuzioni straordinarie
6. Segue: l’emissione di carta moneta
7. Segue: il debito pubblico
7.1 Modalità e tecniche di emissione
7.2 Classificazione e forme dei prestiti pubblici
8. Modalità di estinzione del debito pubblico
8.1 L’ammortamento del debito
8.2 La conversione del debito pubblico
8.3 I principali titoli pubblici italiani
9. Il finanziamento della spesa
9.1 La monetizzazione del disavanzo
9.2 La scelta fra debito pubblico e imposta
Capitolo 2: I tributi
1. Il sistema impositivo
1.1 I tributi
1.2 I singoli tributi
2. Le imposte
2.1 Presupposto ed elementi dell’imposta
2.2 Classificazione delle imposte
2.3 Imposte progressive, proporzionali e regressive
2.4 Deduzioni, detrazioni e «tax expenditures»
3. Le tasse
4. I contributi
5. I monopoli fiscali
6. Eccesso di pressione e tassazione ottimale
7. La regola di Ramsey
Capitolo 3: I principi giuridici delle imposte
1. La Costituzione: principi in materia tributaria
2. Le altre fonti del diritto tributario
3. Lo Statuto del contribuente
4. Efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio
5. L’abuso del diritto (o elusione fiscale)
6. Il diritto di interpello
Capitolo 4: La teoria dell’incidenza delle imposte
1. Introduzione
2. La valutazione economica delle imposte
3. Traslazione, ammortamento, diffusione delle imposte
3.1 La traslazione delle imposte
3.2 L’ammortamento delle imposte
3.3 La diffusione delle imposte
4. Traslazione delle imposte sul reddito d’impresa nelle diverse forme di mercato
4.1 Traslazione in regime di concorrenza perfetta
4.2 Traslazione in regime di monopolio
4.3 Traslazione nei regimi di mercato intermedi
5. Altri effetti microeconomici delle imposte: evasione, erosione, elisione ed elusione
5.1 L’evasione
5.2 L’erosione
5.3 L’elisione
5.4 L’elusione
Capitolo 5: Le teorie sui criteri distributivi delle imposte
1. Nozioni generali sui principi distributivi del carico tributario
1.1 Il problema della giusta distribuzione del carico tributario
1.2 Il principio del beneficio
1.3 Il principio della capacità contributiva
2. L’articolazione del sistema tributario
2.1 La scelta tra imposte dirette e indirette
2.2 La pressione tributaria e il teorema di Barone
2.3 I limiti alla pressione tributaria: la curva di Laffer
3. Determinazione della capacità contributiva: il concetto di reddito
3.1 Le definizioni di reddito imponibile
3.2 Il reddito-prodotto
3.3 Il reddito-entrata
3.4 Il reddito-consumo
4. Discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi
Capitolo 6: Il sistema impositivo italiano
Sezione Prima - Le imposte dirette
1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
2. Segue: il reddito complessivo e le singole categorie di reddito
2.1 Il reddito complessivo
2.2 Le singole categorie di reddito
2.3 I redditi fondiari
2.4 I redditi di capitale
2.5 I redditi di lavoro dipendente
2.6 I redditi di lavoro autonomo
2.7 I redditi di impresa
2.8 Segue: la contabilità delle imprese e degli esercenti arti o professioni. Contabilità ordinaria
2.9 Segue: contabilità semplificata per le imprese minori
2.10 Segue: il regime forfettario dei contribuenti minimi
2.11 Segue: la tassazione per gli imprenditori individuali e le società di persone (IRI)
2.12 I redditi diversi
3. Segue: i criteri di applicazione
3.1 Calcolo del reddito complessivo lordo
3.2 Determinazione del reddito imponibile
3.3 Determinazione dell’imposta
3.4 Detrazione delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta
4. Segue: la liquidazione dell’imposta
5. Segue i redditi soggetti a tassazione separata
6. Caratteri generali dell’IRES
7. Segue: le disposizioni comuni a tutti i soggetti d’imposta
7.1 Scomputo degli acconti
7.2 Scomputo delle ritenute
7.3 Riporto o rimborso dell’eccedenza
8. Segue: tassazione di gruppo consolidati fiscali nazionale e mondiale
9. Segue: regime di trasparenza fiscale
Sezione Seconda - L’IVA e le altre imposte indirette
1. Generalità e caratteri dell’imposta sul valore aggiunto
2. Presupposti e territorialità dell’imposta
3. Soggetti passivi
4. La nascita dell’obbligazione tributaria
4.1 Presupposto d’imposta
4.2 Esigibilità dell’imposta
5. La classificazione delle operazioni ai fini IVA
6. Base imponibile e aliquote
7. Il volume d’affari
8. I regimi contabili
9. Meccanismo applicativo dell’IVA
10. Gli obblighi del contribuente
10.1 Le denunce
10.2 Tenuta dei registri obbligatori
10.3 La fatturazione
10.4 La fatturazione elettronica
10.5 Liquidazioni e versamenti
11. Le dichiarazioni
11.1 La dichiarazione annuale
11.2 Le nuove comunicazioni semestrali IVA
12. Versamento di conguaglio e rimborsi
12.1 Il versamento di conguaglio o l’eventuale rimborso dell’eccedenza
12.2 Rimborsi infrannuali
13. Iva di gruppo
14. I sistemi di controllo
15. L’imposta di registro
16. Le imposte ipotecaria e catastale
17. L’imposta di bollo
18. L’imposta sulle successioni e donazioni
Capitolo 7: L’attività statale decentrata: il federalismo fiscale
1. Principi del federalismo fiscale
2. I modelli economici sul decentramento fiscale
2.1 Il modello di Tiebout
2.2 Il teorema del decentramento di Oates
2.3 La teoria dei club di Buchanan
3. Funzioni e livelli di governo
4. I trasferimenti intergovernativi
5. L’effetto della carta moschicida
6. Decentramento amministrativo e federalismo fiscale in Italia
6.1 La Costituzione
6.2 L’attuazione del federalismo fiscale: la L. 42/2009
6.3 I limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: dal patto di stabilità interno ai nuovi obiettivi di finanza pubblica
6.4 La L. cost. 1/2012 e il vincolo del pareggio di bilancio
Capitolo 8: Il sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali
1. I decreti attuativi della L. 42/2009
2. La riforma del sistema impositivo delle Regioni e delle Province: il D.Lgs. 68/2011
3. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4. L’addizionale regionale all’IRPEF
5. Le principali entrate tributarie delle Province
6. La riforma del sistema impositivo dei Comuni: il D.Lgs. 23/2011 sul cosiddetto federalismo fiscale municipale
7. L’imposta unica comunale (IUC)
8. L’imposta municipale propria (IMU)
9. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI)
10. La tassa sui rifiuti (TARI)
Capitolo 9: Le spese pubbliche
1. Concetto di spesa pubblica
1.1 Definizione, fini, presupposti economici
1.2 Spese pubbliche e spese private
1.3 La spesa pubblica e l’attività di spendita
2. Classificazione delle spese pubbliche
3. Cause dello sviluppo delle spese pubbliche
4. La produttività della spesa pubblica e la finanza della sicurezza sociale
5. L’espansione tendenziale e il limite delle spese pubbliche
6. La redistribuzione del reddito
7. Modalità della redistribuzione della spesa pubblica
Capitolo 10: I principali settori d’intervento pubblico: la sicurezza sociale
1. La sicurezza sociale
1.1 Previdenza e sicurezza sociale
1.2 Cenni storici
1.3 La sicurezza sociale e la Costituzione
2. Forme di finanziamento della sicurezza sociale
3. Effetti collaterali dovuti all’incidenza dei contributi sociali
4. Il sistema della sicurezza sociale in Italia
4.1 Il sistema pensionistico
4.2 Sistemi pensionistici a capitalizzazione e a ripartizione
4.3 Sistemi retributivi e contributivi
4.4 La crisi del sistema di finanziamento a ripartizione
4.5 Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita
4.6 I trattamenti pensionistici previdenziali
4.7 Gli anticipi pensionistici
4.8 Previdenza integrativa
4.9 Gli ammortizzatori sociali
4.10 Tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
4.11 L’assegno per il nucleo familiare
5. Segue: i trattamenti assistenziali
5.1 L’assegno sociale per gli ultrasessantacinquenni privi di redditi
5.2 Le prestazioni economiche assistenziali per il nucleo familiare e per la maternità
5.3 Le prestazioni assistenziali agli invalidi civili
5.4 Il reddito di inclusione (ReI)
6. Il Servizio Sanitario Nazionale
Parte III
Il bilancio dello Stato
Capitolo 1: Profili generali
1. Lo Stato e il suo bilancio
2. Le funzioni del bilancio
3. Il bilancio dello Stato italiano (rinvio)
4. I principi del bilancio
Capitolo 2: I vincoli economici e di bilancio derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
1. Il coordinamento delle politiche economiche
2. Il rafforzamento della governance economica europea
2.1 Il semestre europeo
2.2 Il Fiscal Compact
2.3 Le altre riforme per il rafforzamento della governance nell’Unione Economica e Monetaria
3. Il Patto di stabilità e di crescita
Capitolo 3: Le norme che regolano il bilancio dello Stato in Italia
1. La Costituzione e in particolare l’articolo 81
1.1 La L. cost. 20 aprile 2102, n. 1 e l’introduzione nell’articolo 81 del vincolo del pareggio del bilancio
1.2 La modifica degli articoli 97, 117 e 119
2. La legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009)
320 Indice generale
2.1 L’adeguamento dei sistemi contabili
2.2 La definizione di amministrazioni pubbliche nella L. 196/2009
3. La legge attuativa del principio del pareggio di bilancio (L. n. 243 del 2012)
Capitolo 4: Il ciclo del bilancio
1. Il ciclo del bilancio e il principio della programmazione
2. I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica: il Programma di stabilità, il Programma nazionale di riforma e il Documento programmatico di bilancio
2.1 Il PSC e il PNR
2.2 Il Documento programmatico di bilancio
3. Il Documento di economia e finanza (DEF)
4. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
5. Il bilancio di previsione e la «nuova» legge di bilancio
5.1 La prima sezione della legge di bilancio
5.2 La seconda sezione della legge del bilancio
5.3 La presentazione e l’approvazione del bilancio
6. La programmazione delle risorse finanziarie e gli Accordi tra Ministeri
7. I fondi di bilancio
8. I residui
9. Il rendiconto generale dello Stato
Test di autovalutazione
Risposte esatte

 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università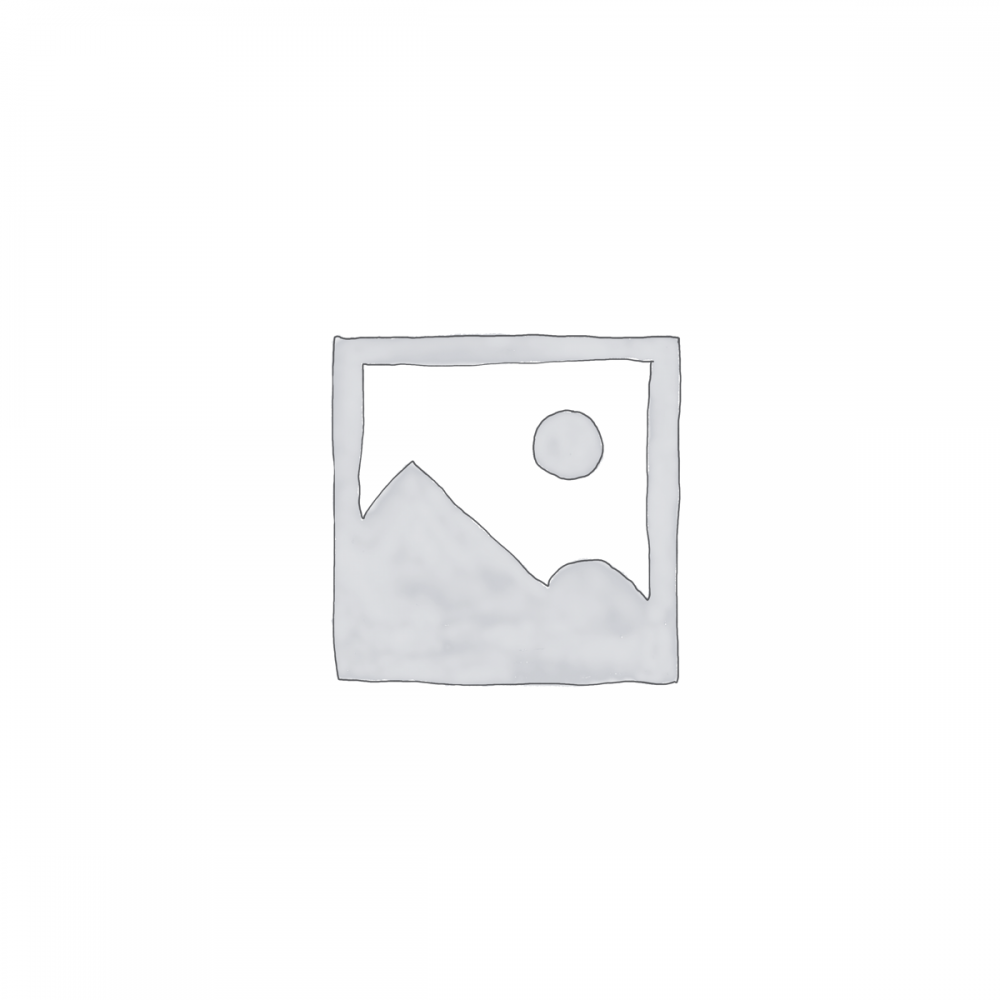







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.