Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
![]()
![]()
La Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – SE/D36
35,00€ Il prezzo originale era: 35,00€.33,25€Il prezzo attuale è: 33,25€.
 Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
– Procedura – Organismi e sanzioni – Liquidazione del patrimonio – Profili fiscali
Esaurito
La riforma della legge fallimentare, iniziata nel 2005 e forse ancora non conclusasi (nel corso degli anni si è assistito a una modificazione continua e ripetuta) ha radicalmente mutato istituti e concetti consolidati nel tempo nonché comportamenti che rivoluzionano i flussi informativi tra il curatore e i creditori – che devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) – e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo da inviare esclusivamente alla PEC del curatore.
La nuova legge fallimentare, tra l’altro:
— ha confermato l’esclusione dal fallimento e dal concordato preventivo del piccolo imprenditore identificato in base a parametri numerici (investimenti e ricavi);
— ha ridistribuito i poteri degli organi procedurali;
— ha introdotto una filosofia nuova, secondo la quale l’impresa non è più concepita come un bene strettamente personale dell’imprenditore ma un “bene” del sistema economico, un bene da assistere, tutelare e conservare anche nel momento in cui l’imprenditore entra in crisi;
— ha introdotto l’istituto dell’esdebitazione che consente al fallito, ove ricorrano determinate condizioni, di cancellare i debiti che non hanno trovato soddisfazione in abito concorsuale;
— ha rivisitato in maniera profonda l’istituto del concordato preventivo sminuendo i poteri di controllo e di indagine degli organi della procedura, abrogando il criterio della meritevolezza e, nel contempo, accentuando la
natura contrattualistica tra le parti;
— ha introdotto la procedura di concordato “in bianco” consentendo al debitore di depositare il ricorso riservandosi di presentare la proposta e la documentazione nel termine assegnato (art. 161 L.F.);
— ha introdotto il nuovo istituto della degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.) e del piano attestato (art. 67 L.F.) per la soluzione ragionata della crisi d’impresa;
— ha ridisegnato la procedura della transazione fiscale (art. 182ter L.F.), consentendo all’imprenditore in difficoltà di poter risolvere la crisi d’impresa attraverso procedure chiare e legittime prima che la stessa diventi irreparabile senza costringerlo a dover nascondere la sua situazione attraverso manovre rischiose o ricorrendo ad operazioni e finanziamenti illegittimi.
Nella riforma, però, non ha trovato, in alcun modo, spazio una tutela per i soggetti non fallibili che, anche a seguito della crisi finanziaria importata dall’America nell’estate del 2008, sono stati aggrediti in maniera sempre più massiccia dei creditori con esecuzioni individuali.
In tale situazione la richiesta di tutela per i debitori deboli si è fatta sempre più insistente e diffusa.
La richiesta è stata accolta con il disegno di legge Centaro (307-B) del 2009, ma alla fine del 2011, il governo, non ritenendo più procrastinabile la situazione generale, ricorrendo a un provvedimento d’urgenza, ha introdotto, con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento cui potevano far ricorso i soggetti esclusi dalle procedure concorsuali, al fine di raggiungere un accodo con i propri creditori in sede protetta con l’ausilio di un soggetto particolare (l’organismo di composizione della crisi).
La decretazione con provvedimento d’urgenza ha spinto l’organo legislativo ad approvare il disegno di legge rivisitato che è sfociato nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, ed a stralciare dal D.L. 212/2011 in conversione il Capo 1 che regolava la predetta procedura.
Nella fase transitoria e in attesa che sia emanato l’apposito decreto da parte del ministro della giustizia per l’istituzione degli organismi di composizione della crisi, le funzioni e compiti loro spettanti saranno svolti da un soggetto in possesso dei requisiti per assumere la carica di curatore fallimentare (art. 28 L.F.) o da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
La funzione della legge 3/2012 è quella di coprire la zona della non “fallibilità” e fornire soluzioni ragionate in ambito protetto per la soluzione della crisi da sovraindebitamento.
Da un controllo in alcuni tribunali è emerso che nessuna procedura è stata richiesta a Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia ed un solo ricorso è stato depositato al tribunale di Roma e a quello di Firenze evidenziando che la legge, come improntata (una accordo tra debitore e creditori o parte di essi), ha tradito le aspettative con la necessità, quindi, di modificarla affinché potesse incidere in maniera significativa sul fenomeno, sempre più crescente, della crisi dei piccoli soggetti.
Il governo, alla luce delle prime indagini applicative, ha ritenuto urgente e improcrastinabile l’intervento della legge ed ha emanato il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 al fine di aumentare l’efficacia e l’operatività apportando modifiche di notevole portata.
In particolare:
— la procedura diventa concorsuale;
— viene definito il “consumatore” destinatario di una particolare procedura;
— viene modificato il contenuto del piano prevedendo anche un pagamento non integrale dei creditori privilegiati (esclusi alcuni soggetti);
— riduce la percentuale per il raggiungimento dell’accordo dal settanta al sessanta per cento;
— disciplina un autonomo procedimento per l’omologazione del piano del consumatore;
— introduce procedure alternative per la liquidazione di tutti i beni;
— condiziona all’esito della liquidazione ed al giudizio del tribunale l’effetto della esdebitazione;
— introduce una particolare procedura per il consumatore contrassegnata dall’assenza di un procedimenti di acquisizione dell’adesione o del dissenso dei creditori basata esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e della meritevolezza della condotta d’indebitamento del soggetto;
— prevede che le start-up (definite dall’art. 25 del D.L. 179/2012) siano soggette alle procedura regolate dal Capo II.
SE/D36
Parte I
Dalla riforma della legge fallimentare alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
1
Cenni sulla riforma della legge fallimentare e sull’introduzione, delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
1. La riforma della legge fallimentare (cenni)
1.2 L’imprenditore non soggetto al fallimento e al concordato preventivo
1.3 La platea dei soggetti “non fallibili”
1.4 La crisi finanziaria e la crescita dell’indebitamento
1.5 La prima iniziativa a tutela dei “soggetti deboli”
1.6 L’introduzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
1.7 L’approvazione della legge n. 3/2012
1.8 Finalità chiare per una procedura tutta da scoprire
1.9 La necessità di modificare la legge n. 3/2012
1.10 La nuova struttura delle legge n. 3/2012
1.11 E ntrata in vigore delle modifiche portate dal D.L. 179/2012
2
La crisi da sovraindebitamento: finalità e definizione
2.1 La modifica della rubrica dell’articolo
2.2 La finalità
2.3 L’iniziativa
2.4 La definizione di sovraindebitamento
2.5 Sovraindebitamento patrimoniale
2.6 Il sovraindebitamento per incapacità di adempiere regolarmente
le obbligazioni
2.7 Il consumatore
3
I presupposti di ammissibilità
3.1 Il presupposto soggettivo del debitore
3.1.1 Il presupposto soggettivo del debitore (segue)
3.1.2 Il presupposto soggettivo, l’imprenditore agricolo
3.2 Il debitore non imprenditore
3.2.1 Il debitore non imprenditore (segue)
3.3 Gli enti privati non profit
3.4 Gli enti pubblici
3.5 L’assenza di recidività
3.6 Altri impedimenti soggettivi
3.7 La previsione del piano secondo la legge originaria e dopo le modifiche
3.8 I creditori estranei e quelli privilegiati
3.9 I crediti erariali e previdenziali
3.10 Il contenuto del piano
3.10.1 Il contenuto del piano (segue)
4
Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore
4.1 Il contenuto della proposta
4.2 L’intervento di terzi
4.3 La eventuale limitazione al credito del debitore
4.4 La moratoria nel pagamento dei soggetti estranei all’accordo
4.5 La moratoria dopo le modifiche
5
Il deposito della proposta e gli adempimenti connessi
5.1 La competenza territoriale
5.2 La presentazione della proposta e i documenti da allegare come previsto inizialmente
5.3 Il deposito della proposta dopo le modifiche
5.4 Gli effetti del deposito della proposta
5.5 Il patrocinio legale
6
Il procedimento
6.1 Il giudice
6.2 I controlli iniziali del giudice
6.3 Il procedimento camerale
6.4 Il provvedimento del giudice
6.5 L’apertura della procedura
6.6 L’oggetto dell’udienza
6.7 I provvedimenti in sede di udienza prima delle modifiche
6.7.1 I provvedimenti in sede di udienza dopo le modifiche
6.8 La sospensione delle procedure esecutive
6.9 La proponibilità della richiesta di fallimento
6.10 Gli atti di straordinaria amministrazione
7
Il raggiungimento dell’accordo
7.1 L’espressione del consenso
7.2 La modificabilità della proposta
7.3 Il raggiungimento della maggioranza
7.4 I diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati
7.5 L’eventuale effetto novativo dell’accordo
7.6 La revoca di diritto dell’accordo a tutela di particolari creditori
7.7 La cessazione di diritto dell’accordo e l’eventuale revoca
8
L’omologazione dell’accordo
8.1 Il raggiungimento del quorum
8.2 Il mancato raggiungimento del quorum
8.3 Le eventuali contestazioni dei creditori
8.4 Il contenuto e il destinatario delle contestazioni
8.5 La comunicazione al giudice
8.6 I controlli del giudice
8.7 L’omologazione e gli effetti prima della novella
8.7.1 L’omologazione dopo la novella, effetti e decadenza
8.8 I reclami avverso i provvedimenti del giudice
8.9 L’eventuale dichiarazione di fallimento dopo l’omologazione
9
Procededimento ed omologazione del piano del consumatore
9.1 La previsione espressa del procedimento di omologazione del piano del consumatore
9.2 Il provvedimento iniziale del giudice e i relativi controlli
9.3 L’udienza dinanzi al giudice
9.4 L’omologazione o il diniego
10
Gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore
10.1 L’obbligatorietà del piano omologato
10.2 Il mancato pagamento dei creditori
11
Esecuzione dell’accordo e del piano del consumatore
11.1 L’esecuzione dell’accordo e la nomina del liquidatore
11.2 Il liquidatore
11.3 L’attività del giudice dopo l’omologazione
11.4 La disposizione di tutela per i creditori prima e dopo la novella
11.5 I crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento
11.6 I compiti dell’organismo di composizione della crisi
12
L’impugnazione e la risoluzione dell’accordo
12.1 Impugnazione e risoluzione
12.2 L’annullamento dell’accordo
12.3 La legittimazione attiva e quella passiva
12.4 La risoluzione dell’accordo
12.5 La legittimazione attiva e quella passiva
12.6 La proposizione dell’azione di annullamento e di risoluzione
12.7 Gli effetti dell’annullamento e della risoluzione
12.8 Il gravame avverso il provvedimento del tribunale
13
La revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano
del consumatore
13.1 La cessazione di diritto dell’accordo e l’eventuale revoca
13.2 Cessazione degli effetti dell’omologazione da parte del tribunale
13.3 I diritti acquisiti dai terzi in caso di cessazione degli effetti dell’omologazione
Parte II
La liquidazione del patrimonio
14
La liquidazione dei beni
14.1 L’introduzione di una nuova procedura
14.2 I soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni
14.3 Il tribunale competente a ricevere la domanda
14.4 La documentazione da allegare alla domanda
14.5 La notizia all’agente della riscossione
14.6 I beni esclusi dalla liquidazione
14.7 Gli effetti del deposito della proposta
15
La conversione della procedura di composizione in liquidazione
e l’apertura della liquidazione
15.1 La conversione
15.2 I controlli del giudice in fase di apertura della liquidazione
15.3 Il contenuto del provvedimento del giudice
15.4 La durata della procedura
16
L’inventario e l’elenco dei creditori
16.1 L’attività iniziale del liquidatore
16.2 L’inventario
16.3 La comunicazione ai creditori
17
La domanda di partecipazione alla liquidazione
17.1 Forma e sottoscrizione della domanda
17.2 Dove si deposita la domanda
17.3 Il contenuto della domanda
18
La formazione del passivo
18.1 L’esame delle domande e la formazione del progetto di stato passivo
18.2 L’approvazione dello stato passivo o l’intervento del giudice
19
Il programma di liquidazione e la realizzazione dei beni
19.1 Il programma di liquidazione
19.2 La liquidazione dei beni e dei diritti
19.3 La vendita di immobili in presenza del creditore fondiario
19.4 La purgazione delle formalità pregiudizievoli
19.5 La chiusura della procedura
20
Le azioni del liquidatore. I beni e i crediti sopravvenuti
20.1 La legittimazione attiva del liquidatore
20.2 I beni e i crediti sopravvenuti
21
I creditori posteriori
21.1 I creditori posteriori
21.2 I crediti sorti in occasione della liquidazione
Parte III
Gli organismi di composizione
della crisi e le sanzioni
22
Gli organismi di composizione della crisi
22.1 Gli organismi di composizione della crisi
22.2 La costituzione degli organismi di composizione della crisi
22.3 L’iscrizione nel registro
22.4 L’abrogazione dell’iscrizione di diritto nel registro
22.5 I compiti dell’organismo di composizione della crisi
22.6 L’organo di composizione quale liquidatore
22.7 Le modalità per le comunicazioni
22.8 I professionisti quali organismi di composizione della crisi
22.9 Compensi spettanti all’organismo di composizione
22.10 Le banche dati
22.11 L’accesso alle banche dati
22.11.1 L’accesso alle banche dati (segue)
22.12 La conservazione dei dati personali
23
Le sanzioni e l’entrata in vigore
23.1 L’art. 16 prima e dopo il D.L. 179/2012
23.2 Le sanzioni, cenni generali
23.3 I reati propri del debitore
23.4 I reati propri dell’organismo di composizione della crisi o del professionista
23.5 Le false attestazioni
23.6 L’omissione o il rifiuto ingiustificato di compiere atti d’ufficio
23.7 Entrata in vigore delle nuove sanzioni
Parte IV
Le norme abrogate dall’art. 18 del D.L. n. 179/2012
24
Organismo di composizione della crisi
24.1 I compiti dell’organismo di composizione della crisi
24.2 La responsabilità dell’organismo
25
L’accesso alle banche dati pubbliche
25.1 Le banche dati
25.2 L’accesso alle banche dati
25.3 L’accesso alle banche dati (segue)
25.4 La conservazione dei dati personali
26
Le sanzioni
26.1 Cenni generali
26.2 I reati propri del debitore
26.3 I reati propri dell’organismo di composizione della crisi
26.4 Le false attestazioni
26.5 L’omissione o il rifiuto ingiustificato di compiere atti d’ufficio
27
Le disposizioni transitorie e finali
27.1 Le disposizioni secondarie
27.2 Il periodo transitorio
27.3 L’emanazione delle tariffe applicabili
27.4 La necessità di una lunga vacatio legis
Parte V
La composizione della crisi
da sovraindebitamento ex D.L. 212/2011
Le start-up innovative e le procedure concorsuali
28
La composizione della crisi da sovraindebitamento secondo il d.l. 212/2011
28.1 L’introduzione della procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento
28.2 La figura del consumatore
28.3 Il diverso quorum per il raggiungimento dell’accordo
28.4 La breve vita del D.L. 212/2012
28.5 Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212
29
Le start-up innovative e le procedure concorsuali
29.1 La definizione di start-up innovativa
29.2 L’esclusione delle start-up innovative della procedure fallimentari
29.3 L’applicazione di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012
Parte VI
Profili fiscali
30
Profili fiscali
30.1 L’imposta sul valore aggiunto
30.1.1 Generalità
30.1.2 L’irrilevanza della procedura
30.1.3 La garanzia per il rimborso del credito IVA
30.1.4 Il necessario coordinamento tra debitore e liquidatore
30.1.5 La soddisfazione del creditore con dazione di beni
30.1.6 Le problematiche per i creditori, le note di credito per sola IVA
30.1.7 L’IVA ad esigibilità differita
30.1.7.1 L’IVA ad esigibilità differita (segue)
30.2 Le imposte dirette
30.2.1 Generalità
30.2.2 La indifferenza dell’accesso alla procedura o dell’omologazione dell’accordo
30.2.3 La rilevanza ai fini delle II.DD. in caso di soddisfazione con dazione di beni
30.2.4 Le perdite subite dai terzi
30.3 L’imposta regionale sulle attività produttive
30.3.1 Generalità
30.3.2 L’irrilevanza della procedura
30.4 Il sostituto d’imposta
30.4.1 Il sostituto d’imposta, cenni
30.4.2 L’irrilevanza della procedura
30.5 L’imposta municipale propria (IMU)
30.5.1 L’imposta municipale propria, cenni
30.5.2 La titolarità del diritto reale
30.6 La compensazione dei crediti
30.6.1 La compensazione dei crediti, cenni
30.7 L’imposta di registro
30.7.1 Il decreto di omologazione
30.8 Il processo tributario
30.8.1 L’assistenza obbligatoria del soggetto abilitato
30.8.2 Il reclamo e la mediazione nel processo tributario
30.8.3 La legittimazione processuale del debitore
30.8.4 La notifica degli atti impositivi
Appendice
L. 27-1-2012 n. 3 – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012) — Stralcio
D.L. 18-10-2012 n. 179 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, S.O.) — Articoli estratti
R.D. 16 marzo 1942, n. 267. — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa
Bibliografia

 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università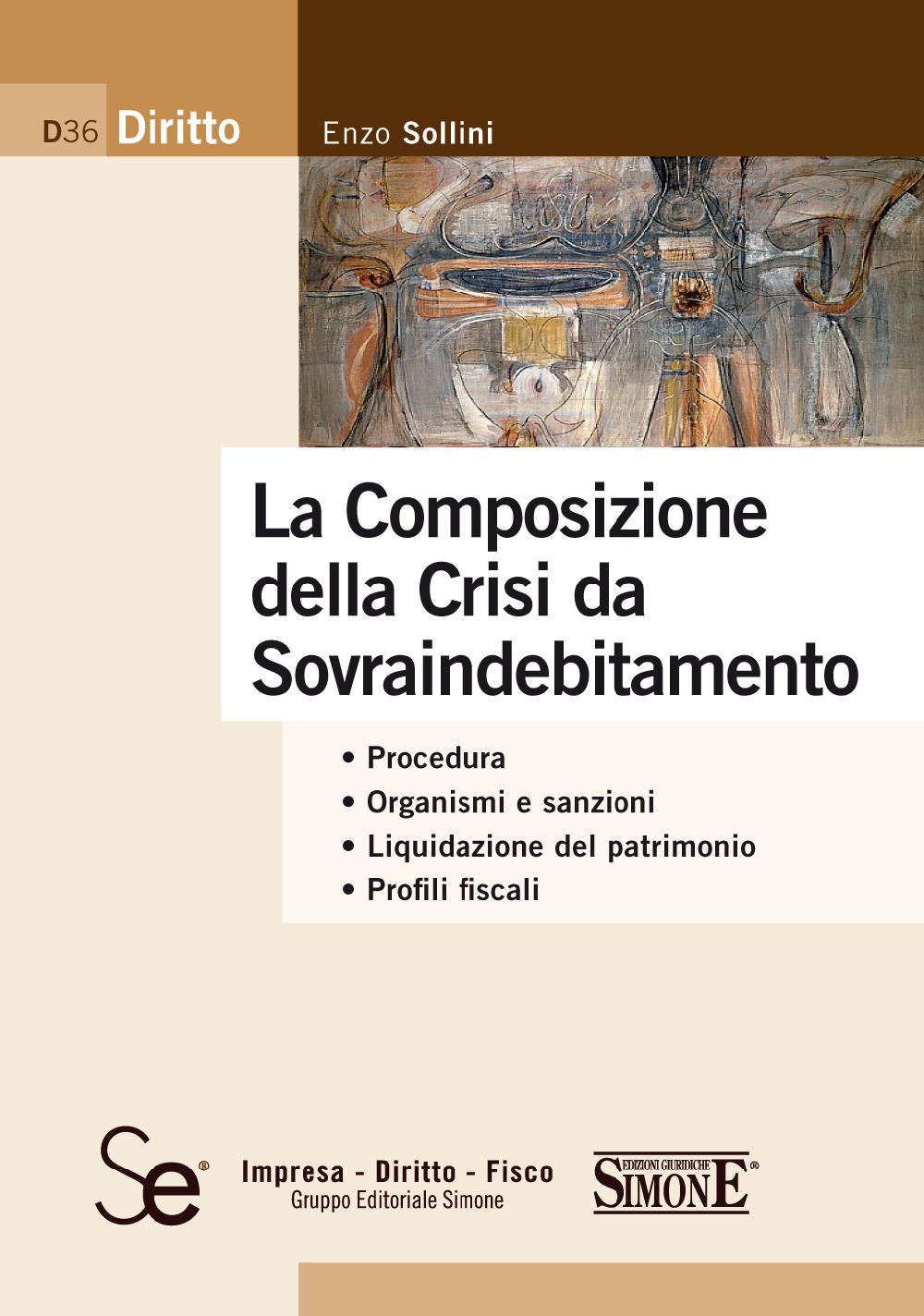






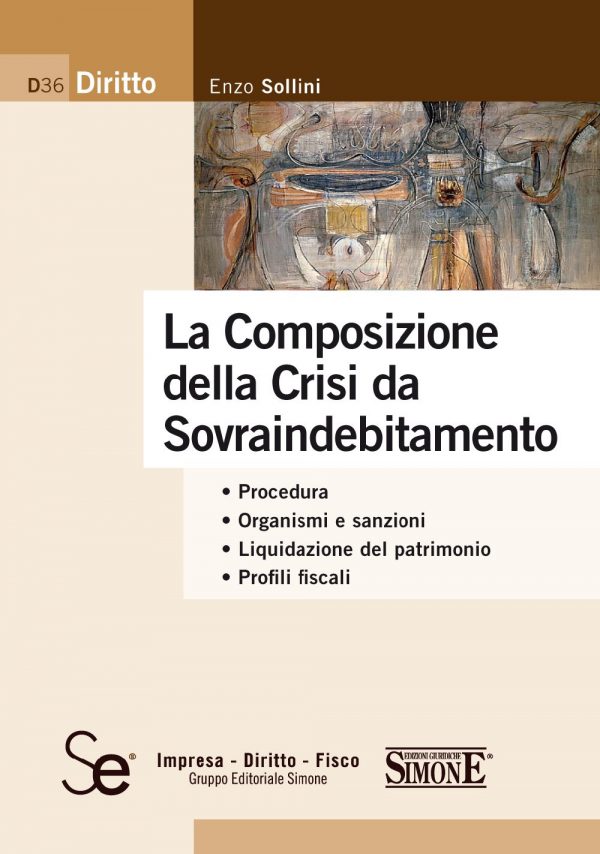
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.