Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
![]()
![]()
L’insegnante nella scuola d’infanzia
30,00€
 Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Paga in tre rate senza interessi con PayPal per ordini superiori a 30 euro.
Manuale per la preparazione ai concorsi e per l’aggiornamento professionale – Aggiornata al ‘Regolamento Gelmini’ sulla scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione (D.P.R. 89/2009) e al relativo Atto di indirizzo di applicazione
Esaurito
Proposto in un’edizione interamente rinnovata, il volume è un manuale completo per la preparazione ai concorsi di insegnante nelle scuole dell’infanzia, nonché un valido supporto per l’aggiornamento professionale.
Essere docenti in questo tipo di scuola — come sottolineavano già gli Orientamenti del 1991, documento di valore insuperato in ambito pedagogico e didattico — «comporta oggi un profilo di alta complessità e di grande responsabilità e richiede la padronanza di specifiche competenze culturali, pedagogiche, psicologiche, metodologiche e didattiche unite ad un’aperta sensibilità e disponibilità alla relazione educativa con i bambini». Appare infatti evidente la rilevanza del ruolo educativo in una scuola che accoglie bambini in un momento cruciale di crescita e deve favorire «l’apprendimento di comportamenti fondamentali e di conoscenze iniziali utili per acquisire le competenze successive e per rapportarsi con la società» (Atto di indirizzo, 8 settembre 2009). Dagli Orientamenti fino ai documenti più recenti, sono sempre state evidenziate le alte e importanti finalità della scuola dell’infanzia che intende «promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza» (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, 2007).
Nonostante alcune differenze che si possono ravvisare nei bandi di concorso, è possibile determinare le conoscenze e competenze richieste all’insegnante della scuola dell’infanzia. Innanzitutto, la conoscenza critica dei vari documenti che negli anni hanno definito il progetto educativo della scuola dell’infanzia, trasformando tale istituzione da servizio prevalentemente assistenziale a scuola per il bambino, nel quadro di un più ampio e complesso percorso di riforma della scuola. Per espletare le nuove funzioni educative e formative a cui sono chiamati i docenti sono quindi necessarie precise competenze in ambito pedagogico, psicologico, metodologico e didattico. Infine, per il superamento dei concorsi, si richiedono nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alle autonomie locali.
In una trattazione puntuale e approfondita ma, al tempo stesso, agile, chiara, ricca di spunti operativi, il manuale affronta i diversi argomenti, al fine di garantire una preparazione esauriente e sicura.
Il testo, pertanto, si articola in sei sezioni:
— La scuola dell’infanzia nel quadro della riforma: delinea attraverso un’ampia lettura dei documenti nazionali e numerose indicazioni metodologiche, il ruolo e le attività dell’insegnante nella scuola dell’infanzia, che ha conosciuto profonde trasformazioni dalla stagione di riforme, iniziata negli anni Novanta, a oggi.
— Una scuola che dialoga con la società: punta l’attenzione sull’utilizzo nelle scuole delle nuove tecnologie e sull’imprescindibile questione diversità e integrazione.
— Una scuola che ricerca: espone le metodologie didattiche in una scuola, come quella dell’infanzia, che si connota più di ogni altra come “scuola dell’accoglienza”.
— Educazione alla salute e igiene scolastica: parte dedicata all’igiene ed educazione sanitaria, alimentazione, malattie infettive dell’infanzia e loro profilassi.
— Lineamenti di psicologia dell’età evolutiva: la trattazione spazia dalle principali teorie dello sviluppo alle psicopatologie specifiche dell’infanzia.
— Diritto amministrativo con particolare riferimento alle autonomie locali: nozione e fonti di diritto amministrativo, la Pubblica Amministrazione (i soggetti, le posizioni giuridiche soggettive, l’attività, la responsabilità della P.A. e verso la P.A., la giustizia amministrativa); l’ordinamento delle autonomie locali; il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
A completamento dell’opera, un’appendice propone le carte internazionali dei diritti del bambino e i più significativi riferimenti alla legislazione settoriale di livello nazionale.
360
“
PARTE I
LA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL QUADRO DELLA RIFORMA
Capitolo 1 - La stagione delle riforme: dagli anni ’90 ad oggi
1. Premessa
2. La scuola di fine millennio
2.1 Produttività e qualità dell’istruzione
2.2 L’autonomia delle istituzioni scolastiche
2.3 Profondi cambiamenti sul piano pedagogico e organizzativo
3. La scuola agli inizi del terzo millennio
4. Il docente oggi: profilo professionale
Capitolo 2: La scuola tra presente e futuro: un cantiere aperto
1. L’avvio della riforma del sistema scolastico: la legge 28 marzo 2003, n. 53
2. Le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione: il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
3. I documenti nazionali: introduzione
4. I documenti nazionali: conoscenza
4.1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione (6-14 anni)
4.2 Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell’infanzia
Capitolo 3: La scuola dell’infanzia dalle Indicazioni del curricolo 2007 all’Atto di indirizzo 2
1. Una nuova stagione di cambiamenti
2. Indicazioni per il curricolo (D.M. 31 luglio 2007): introduzione
3. Indicazioni per il curricolo: conoscenza
4. La revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: il D.P.R n. 89 del 20 marzo 2009
5. L’armonizzazione delle Indicazioni e l’essenzializzazione dei curricoli: un’opportunità progettuale per le scuole dell’autonomia (Atto di indirizzo 8 settembre 2009)
Capitolo 4: Il progetto educativo della scuola dell’infanzia
1. Gli interventi normativi
2. Una lettura comparativa
Capitolo 5: Il Piano dell’Offerta Formativa: una scuola a misura di ciascun bambino
1. La progettazione dei docenti
2. La dimensione organizzativa (il curricolo implicito)
3. Il progetto formativo (il curricolo esplicito)
Capitolo 6: Progetti/Unità di apprendimento
1. I Progetti/Unità di apprendimento: caratteristiche e finalità
2. Progetto/Unità di apprendimento: Il sé e l’altro
2.1 La descrizione del campo di esperienza
2.2 Il progetto: La storia di Cipì
3. Progetto/Unità di apprendimento: Il corpo e il movimento
3.1 Le descrizione del campo di esperienza
3.2 Il progetto: Caccia al tesoro
4. Progetto/Unità di apprendimento: Fruizione e produzione di messaggi/Linguaggi, creatività, espressione
4.1 La descrizione del campo di esperienza
4.2 Il progetto: I colori intorno a noi
5. Progetto/Unità di apprendimento: I discorsi e le parole
5.1 La descrizione del campo di esperienza
5.2 Il progetto: Dalla preconvenzionalità alla convenzionalità linguistica. Indagine su lettura e scrittura
6. Progetto/Unità di apprendimento: Esplorare, conoscere e progettare/La conoscenza del mondo
6.1 La descrizione del campo di esperienza
6.2 Il progetto: La natura intorno a noi
6.3 Il progetto: Una proposta di tipo narrativo per l’apprendimento di concetti scientifici di base
PARTE II
UNA SCUOLA CHE DIALOGA CON LA SOCIETÀ
Capitolo 1: Tecnologie a scuola
1. Le tecnologie didattiche
2. Scuola, mass-media e new-media
3. Computer e handicap
4. Il computer e la scuola dell’infanzia: un’esperienza
4.1 Il computer fra ragione ed emozione: rappresentazioni di bambini/e
4.2 Il computer tra ragione ed emozione: rappresentazioni adulte
Capitolo 2: Il gioco
1. L’importanza del gioco nello sviluppo del bambino
2. Gli spazi per il gioco
Capitolo 3: Diversità e integrazione
1. Le situazioni di svantaggio socioculturale e di diversa abilità
1.1 Lo svantaggio socioculturale
1.2 I diversamente abili
2. Gli interventi metodologico-didattici
Capitolo 4: Profilo storico-normativo dell’integrazione degli alunni diversamente abili
1. Il quadro normativo prima della legge 104/92
2. La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 5 febbraio 1992, n. 104)
3. Il piano educativo individualizzato
PARTE III
UNA SCUOLA CHE RICERCA
Capitolo 1: Accogliere
1. Il concetto di accoglienza: riflessioni
1.1 Il punto di vista filosofico: Martin Heidegger
1.2 Il punto di vista pedagogico: Luigina Mortari
2. Il gruppo modenese: la cura dell’accoglienza nella cornice della personalizzazione
3. Il gruppo ferrarese: l’accoglienza, modo di essere e di proporsi della scuola dell’infanzia
Capitolo 2: Una esperienza di auto-formazione
1. Un modello di progettazione integrata
2. Considerazioni
Capitolo 3: Il portfolio
1. Il portfolio: valutazione come comunicazione
2. Un modello di portfolio
PARTE IV
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E IGIENE SCOLASTICA
Capitolo 1: Principi di educazione sanitaria e igiene scolastica
1. La tutela della salute
2. Il concetto di educazione sanitaria
3. Nozioni di igiene
4. Igiene della scuola
5. Educazione sanitaria a scuola
5.1 Educazione alimentare
5.2 Rispetto dell’ambiente
6. L’igiene dell’ambiente scolastico
Capitolo 2: Le principali malattie infettive e loro profilassi
1. Le malattie infettive: agenti e canali di contagio
2. Le virosi esantematiche
3. Altre malattie infettive
4. Prevenzione e vaccinazioni
PARTE V
LINEAMENTI DI PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Capitolo 1: Storia e modelli dello sviluppo
1. Concetto e storia della psicologia dello sviluppo
1.1 Definizioni di base
1.2 Modelli teorici e clinici
1.3 Strutture del processo evolutivo
1.4 Le origini della psicologia dello sviluppo
2. La teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget
2.1 L’epistemologia genetica
2.2 Elementi dello sviluppo
3. Ambiente e sviluppo (Vygotskij)
4. Le teorie psicoanalitiche dello sviluppo
4.1 L’approccio psicoanalitico di Freud
4.2 Anna Freud
4.3 Lo sviluppo psico-sociale di Erikson
4.4 Melanie Klein
4.5 Winnicott: dalla psicoanalisi infantile al concetto di Sé
4.6 Heinz Kohut
4.7 L’identità di genere in Stoller
5. Etologia e attaccamento (Bowlby)
Capitolo 2: Crescita e sviluppo motorio
1. Genetica e sviluppo
2. Crescita e sviluppo pre- e post-natale
3. Lo sviluppo del sistema nervoso
4. Lo sviluppo motorio del feto
5. Lo sviluppo motorio post-natale
5.1 Modello maturativo
5.2 Modello cognitivo
5.3 Modello dei sistemi dinamici
Capitolo 3: L’evoluzione della funzione percettiva
1. Introduzione
2. Ipotesi sullo sviluppo della funzione percettiva
2.1 La teoria della Gestalt
2.2 L’approccio psicogenetico (Piaget)
2.3 Il modello empiristico di Hebb
2.4 Il modello di Bruner
2.5 La teoria della differenziazione percettiva
3. La percezione dall’età neo-natale a quella della fanciullezza
3.1 La percezione nella vita intrauterina
3.2 Lo sviluppo della percezione
Capitolo 4: La dimensione cognitiva
1. Introduzione
2. Elementi di base dello sviluppo cognitivo
2.1 Il punto di vista di Piaget
2.2 Il punto di vista dei cognitivisti: Bruner
2.3 Le ipotesi di Katherine Nelson
Capitolo 5: Dimensione sociale e sviluppo individuale
1. Quadro teorico e concettuale
2. Lo sviluppo sociale e le sue tappe
2.1 La prima infanzia
2.2 L’età prescolare
2.3 La fanciullezza
2.4 La preadolescenza e l’adolescenza
Capitolo 6: I problemi psicologici specifici dell’età infantile
1. Aspetti generici dei disturbi dell’età evolutiva
2. Il ritardo mentale
3. Disturbi cognitivi e motori
4. I disturbi generalizzati dello sviluppo
4.1 Definizioni e concetti di base
4.2 Autismo infantile idiopatico: forme di Kanner e di Asperger
4.3 Il disturbo di Rett
4.4 Disturbo disintegrativo della fanciullezza
4.5 Disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato (DGSNAS)
4.6 Schizofrenia ad esordio infantile
5. Il disturbo da depersonalizzazione
6. Le paure e le fobie
7. I disturbi d’ansia
8. La depressione infantile
8.1 Il disturbo depressivo nelle varie fasce d’età
8.2 L’approccio psicoterapeutico
9. Psicopatologia del controllo sfinterico: enuresi ed encopresi
10. Disturbi del comportamento sociale: il disturbo da deficit del controllo degli impulsi
11. I disturbi della condotta
Capitolo 7: L’handicap
1. Storia delle definizioni di handicap
1.1 Le prime interpretazioni cliniche
1.2 Le classificazioni dell’OMS (1981-2001)
1.3 Menomazione e disabilità: distinzioni concettuali
1.4 Il concetto di «disabilità»
1.5 Abilità, capacità, lavoro: questioni e differenze
2. L’handicap in termini psico-sociologici
PARTE VI
DIRITTO AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AUTONOMIE LOCALI
Capitolo 1: Il diritto amministrativo: nozione e fonti
1. Concetto e caratteri
2. Classificazione delle fonti
3. Le fonti secondarie
4. I regolamenti
4.1 Nozione e fondamento
4.2 Limiti alla potestà regolamentare
4.3 Classificazione
5. Le ordinanze
6. Le norme interne della P.A.
6.1 Concetto
6.2 Le fonti delle norme interne
7. La consuetudine
8. La prassi amministrativa
Capitolo 2: Le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo
1. Generalità
2. Il diritto soggettivo
3. L’interesse legittimo
4. L’interesse semplice e l’interesse di fatto
4.1 L’interesse semplice
4.2 Gli interessi di fatto
5. Gli interessi collettivi
5.1 Concetto e caratteri
5.2 Tutela degli interessi collettivi
5.3 Le azioni collettive di risarcimento (class action)
Capitolo 3: La pubblica amministrazione
1. Nozione
2. Gli enti pubblici
2.1 Enti pubblici e privati
2.2 Classificazioni interne agli enti pubblici
3. Le potestà degli enti pubblici autarchici
4. Gli enti pubblici economici
5. La struttura degli enti pubblici: organi e uffici, rapporto organico
5.1 Concetti di «ufficio» e di «organo»
5.2 Rapporto organico e rapporto di servizio
5.3 Instaurazione del rapporto organico e di servizio
6. Rapporti interorganici
6.1 Gerarchia
7. La competenza
8. Trasferimento dell’esercizio della competenza
Capitolo 4: L’amministrazione diretta statale
1. Profili generali
2. L’amministrazione statale centrale: organi attivi
3. Organi consultivi
3.1 Il Consiglio di Stato
3.2 L’Avvocatura dello Stato
3.3 Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.)
4. Organi di controllo
4.1 Premessa
4.2 La Corte dei conti: profili generali
5. Le Agenzie
6. Le aziende autonome
7. Le autorità amministrative indipendenti
7.1 Concetti introduttivi
7.2 Le autorità amministrative nel nostro ordinamento
8. L’organizzazione periferica dello Stato
8.1 Il ruolo del Prefetto e le Prefetture – Uffici territoriali del Governo
8.2 Il Sindaco come ufficiale di Governo
Capitolo 5: L’amministrazione indiretta dello Stato
1. Decentramento autarchico
2. Le Regioni
2.1 Generalità e natura
2.2 Caratteri delle Regioni
2.3 Organi
3. I controlli sulle leggi regionali
4. I controlli sugli atti amministrativi delle Regioni
5. I controlli sugli organi delle Regioni
5.1 Il controllo sugli organi delle Regioni a Statuto ordinario
5.2 I controlli sugli organi delle Regioni a Statuto speciale
Capitolo 6: L’attività amministrativa
1. Nozione
2. Elementi e requisiti degli atti amministrativi
2.1 Profili generali
2.2 Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo
2.3 Gli elementi accidentali
2.4 I requisiti
3. Principali tipi di atti amministrativi
3.1 Provvedimenti
3.2 Altri atti amministrativi
4. Il procedimento amministrativo
4.1 Definizione
4.2 Il procedimento amministrativo alla luce della L. 241/1990 e successive modifiche
4.3 Il responsabile del procedimento
4.4 La partecipazione al provvedimento amministrativo
4.5 La partecipazione ai procedimenti degli enti locali
4.6 Le fasi del procedimento amministrativo
5. L’informatizzazione dell’azione amministrativa
5.1 Profili generali
5.2 I nuovi diritti telematici dei cittadini
5.3 La PEC
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
6.1 Profili generali
6.2 I soggetti obbligati a consentire l’accesso
6.3 I limiti
6.4 Modalità di esercizio e tutela giurisdizionale
6.5 Il diritto di accesso e di informazione negli enti locali (art. 10 T.U.E.L.)
7. Stati patologici dell’atto amministrativo
8. L’invalidità dell’atto amministrativo
9. La nullità
10. L’illegittimità
10.1 Nozione e casi
10.2 L’incompetenza
10.3 L’eccesso di potere
10.4 La violazione di legge
10.5 Conseguenze dell’illegittimità
11. L’inopportunità dell’atto amministrativo: i vizi di merito
12. I rimedi contro gli atti illegittimi e inopportuni: generalità
12.1 Tipi di rimedi
12.2 Gli atti di ritiro in generale
13. L’annullamento d’ufficio
13.1 Generalità
13.2 Conseguenze dell’annullamento
14. La revoca
15. Convalescenza dell’atto amministrativo
16. Conservazione dell’atto amministrativo
16.1 La consolidazione
16.2 L’acquiescenza
16.3 La conversione
16.4 La conferma
Capitolo 7: Responsabilità della P.A. e verso la P.A.
1. Gli obblighi della P.A.
2. Concetto di responsabilità
3. La responsabilità della P.A. per fatti illeciti
4. La responsabilità nei confronti della P.A.
4.1 La supremazia generale e speciale dello Stato
4.2 La responsabilità civile verso la P.A.
4.3 La responsabilità disciplinare
Capitolo 8: La giustizia amministrativa
1. La tutela contro gli atti amministrativi illegittimi
2. I ricorsi amministrativi
2.1 Generalità
2.2 L’opposizione
2.3 Il ricorso gerarchico
2.4 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
3. Tutela giurisdizionale ordinaria
3.1 Generalità
3.2 La giurisprudenza del G.O. in tema di pubblico impiego
4. Tutela giurisdizionale amministrativa
4.1 Principi generali
4.2 Le azioni esperibili innanzi al G.A.
4.3 Gli atti impugnabili innanzi al G.A.
4.4 I Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.)
4.5 Impugnativa delle sentenze dei T.A.R.
4.6 Il Consiglio di Stato
4.7 Il giudizio di ottemperanza
5. La giurisdizione della Corte dei conti
5.1 Caratteri della giurisdizione
5.2 Ambito della giurisdizione
Capitolo 9: Il Comune: caratteri, elementi costitutivi e funzioni
1. Caratteri fondamentali
2. Elementi costitutivi
3. Il territorio
4. Il decentramento comunale
4.1 I Municipi
4.2 Le Circoscrizioni
5. La popolazione
6. Il patrimonio
7. Funzioni del Comune
7.1 I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione
7.2 Funzioni proprie e funzioni conferite
Capitolo 10: La Provincia: caratteri, elementi costitutivi e funzioni
1. Natura e caratteri
2. Elementi costitutivi
3. La revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province
4. Funzioni della Provincia
5. La Città metropolitana
Capitolo 11: Autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali
1. L’autonomia statutaria
1.1 Nozione
1.2 Caratteri dello Statuto
1.3 Il contenuto dello Statuto
1.4 Approvazione, controllo, pubblicazione ed esecutività dello Statuto
2. La potestà regolamentare degli enti locali
2.1 Generalità
2.2 Tutela giurisdizionale nei confronti dei regolamenti illegittimi
2.3 Tipologia dei regolamenti: art. 7 del T.U.E.L.
Capitolo 12: Organi del Comune: struttura e competenze
1. Gli organi del Comune
2. Il Consiglio comunale
2.1 Composizione
2.2 Durata del mandato
2.3 I consiglieri
2.4 Competenze del Consiglio
2.5 Funzionamento del Consiglio
3. Il Presidente del Consiglio comunale
4. La Giunta
4.1 Natura e ruolo
4.2 Composizione
4.3 Gli assessori
4.5 Competenze della Giunta
5. Il Sindaco
6. Le funzioni del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale
7. Le funzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo
8. Il potere di ordinanza del Sindaco
Capitolo 13: Organi della Provincia: struttura e competenze
1. Gli organi della Provincia
2. Il Consiglio: caratteri generali, funzionamento e competenze
3. La Giunta: caratteri generali e attività
4. Il Presidente della Provincia: natura e competenze
Capitolo 14: I controlli sugli atti e sugli organi degli enti locali
1. Nozione di controllo
2. Il sistema dei controlli nel T.U. degli enti locali
2.1 Il controllo preventivo di legittimità
2.2 Il controllo sostitutivo
2.3 Il potere sostitutivo del Governo
2.4 L’annullamento straordinario
3. La Legge costituzionale 3/2001
4. Lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali
5. La sospensione dei Consigli comunali e provinciali
6. Rimozione e sospensione degli amministratori locali
Capitolo 15: Il pubblico impiego
Sezione Prima
Profili generali del rapporto di pubblico impiego
1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
2. Le novità introdotte dal D.L. 112/2008
3. Il D.Lgs. 27-10-2009, n. 150: cd. «Riforma Brunetta» della pubblica amministrazione
4. Ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001
5. Il sistema delle fonti del pubblico impiego
6. La contrattazione collettiva
6.1 I soggetti della contrattazione
6.2 Il procedimento di contrattazione collettiva
7. Accesso al pubblico impiego
8. Organizzazione degli uffici
9. I doveri dell’impiegato
10. Il D.Lgs. 150/2009 e la misurazione e la trasparenza della performance
11. I diritti patrimoniali dell’impiegato
11.1 In genere
11.2 La retribuzione: regime giuridico
12. I diritti non patrimoniali
13. La mobilità nel pubblico impiego
14. La responsabilità dell’impiegato
15. La responsabilità disciplinare
15.1 Profili generali
15.2 Sanzioni disciplinari e responsabilità nel D.Lgs. 150/2009
15.3 Il licenziamento disciplinare
16. Le vicende modificative del rapporto di impiego
16.1 Successione di enti nel pubblico impiego
16.2 Aspettativa e collocamento in disponibilità
16.3 Comando, distacco, collocamento fuori ruolo e temporaneo servizio all’estero
17. Estinzione del rapporto di impiego
17.1 La disciplina pattizia
17.2 La disciplina pubblicistica
17.3 La disciplina privatistica
Sezione Seconda
Il pubblico impiego nell’ente locale
18. Le fonti del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali
19. L’attuazione della riforma Brunetta negli enti locali
19.1 Ambito di applicazione: l’art. 74 del D.Lgs. 150/2009
19.2 Gli strumenti di verifica dell’efficienza della gestione: la trasparenza
19.3 Misurazione e valutazione della performance
19.4 Meritocrazia e premialità
19.5 La contrattazione integrativa
20. L’organizzazione burocratica
21. Gli uffici di staff
22. Costituzione del rapporto di lavoro
23. La retribuzione
24. Gli obblighi
25. Le forme flessibili di impiego
26. Le competenze dei dirigenti locali
27. Il Direttore generale
28. Il Segretario comunale e provinciale
APPENDICE
DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Dichiarazione di Ginevra del 1924 della Società delle Nazioni Unite
Dichiarazione dei diritti del bambino dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1959
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) (Articoli estratti)
Scuola ed educazione nella Costituzione italiana
D.M. 3 giugno 1991 — Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali
L. 5 febbraio 1992, n. 104 — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Articoli estratti)
D.P.R. 24 febbraio 1994 — Atti di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap
Note di commento all’Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Aziende Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap
L. 15 marzo 1997, n. 59 — Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Articolo estratto)
L. 28 marzo 2003, n. 53 — Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (Articoli estratti)
D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 — Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Articoli estratti)
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 — Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università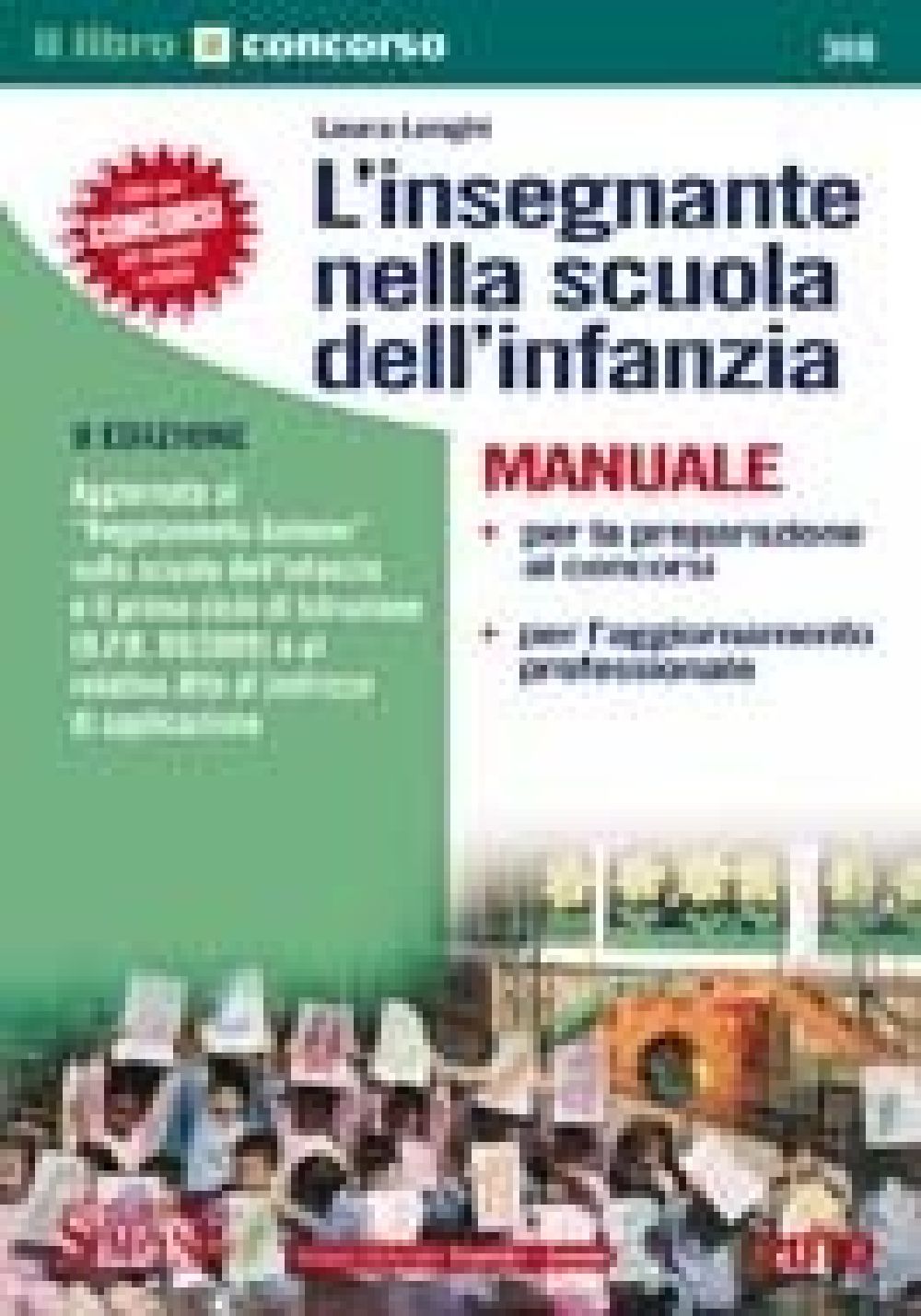
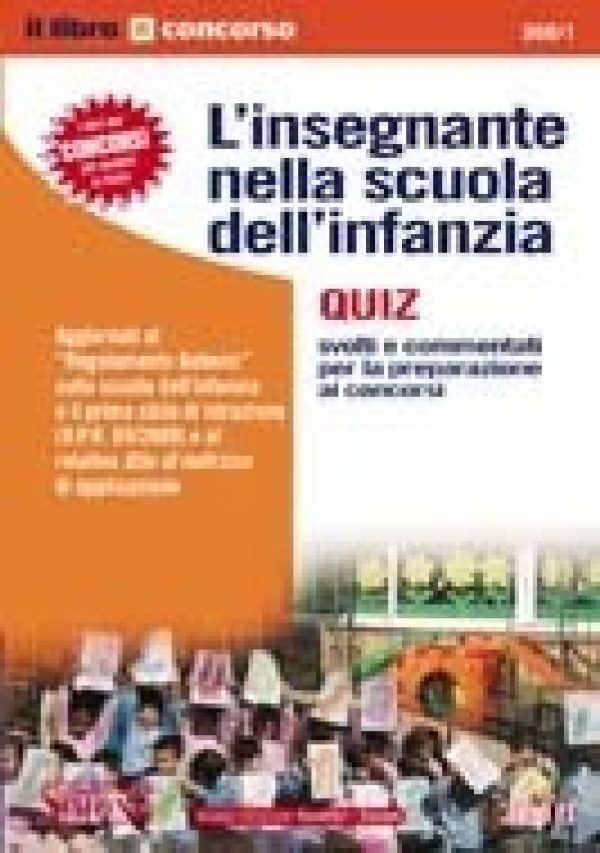






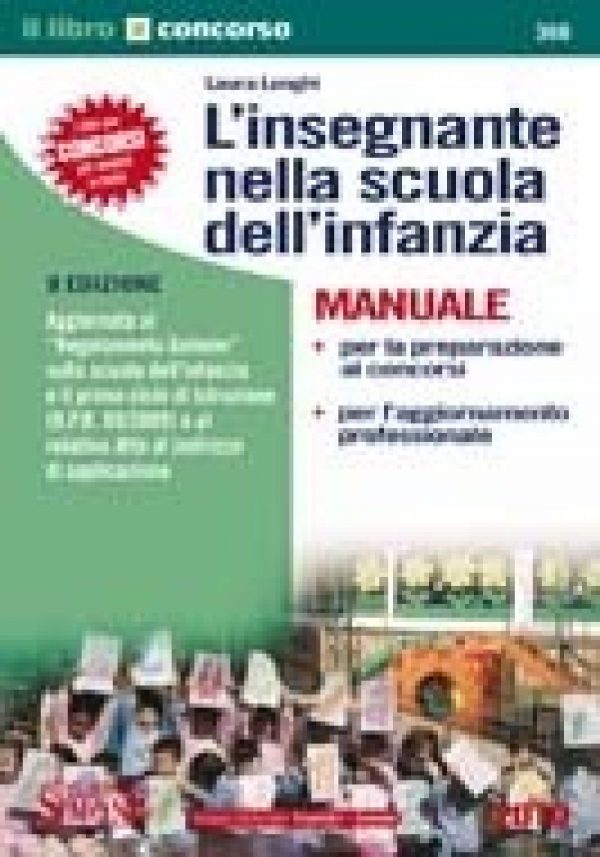
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.