Lo Stato di diritto

Sei alle prese con l’esame di diritto costituzionale? Stai studiando diritto costituzionale per un concorso? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai una spiegazione chiara e semplice dello Stato di diritto.
Lo stato di diritto: origini
Lo Stato liberale costituisce una forma di Stato sviluppatasi in Inghilterra nel XVII secolo al termine della «Gloriosa Rivoluzione» (1688-1689), diffondendosi poi negli Stati Uniti con la guerra d’indipendenza contro l’Inghilterra del 1776 e nel resto d’Europa dopo la Rivoluzione francese (1789).
Esso, che trova il suo fondamento teorico nella corrente politica definita liberalismo, nonché nella diffusione delle dottrine razionaliste e illuministe (a partire dalle opere di Locke, Voltaire, Diderot e Montesquieu), costituì un’innovazione radicale rispetto allo Stato assoluto, in quanto istituiva un sistema inviolabile di garanzie del singolo nei confronti del potere politico. Alcune di queste garanzie si erano già parzialmente affermate in precedenza, prime fra tutte l’istituzione di assemblee rappresentative dei ceti sociali più influenti (clero, nobiltà e borghesia) e il mantenimento di una autonomia, seppur limitata, dei giudici, ma con il progressivo consolidarsi delle monarchie assolute nell’Europa continentale esse persero del tutto il proprio ruolo di contenimento del potere sovrano.
La supremazia della legge
Si stabilì in tale contesto il principio di supremazia della legge (rule of law), che rese lo Stato liberale uno Stato di diritto: tutti i pubblici poteri erano tenuti al rispetto della legge (incluso il sovrano), e l’azione della pubblica amministrazione doveva sottostare al principio di legalità, ossia senza violare la legge e sulla base di una previa norma che le attribuisse poteri e competenze.
Con il termine «legalità», infatti, si intende la conformità alla legge del potere: tutti gli organi statali sono tenuti ad agire nel rispetto delle leggi, salvo casi eccezionali che, per il fatto di essere previsti e disciplinati dalla legge stessa, sono anch’essi legalizzati.
La separazione dei poteri
Si affermò, inoltre, il principio di divisione dei poteri, in base al quale l’organo legislativo, dato il suo carattere rappresentativo, è chiamato a formulare le regole generali e astratte della convivenza civile, l’organo esecutivo ad attuarle e quello giudiziario a giudicare, in modo imparziale ed indipendente, che i comportamenti dei consociati siano conformi ad esse, applicando, in caso contrario, pene e sanzioni ai contravventori.
Benché distinti, tali poteri devono, però, limitarsi a vicenda (cd. principio di bilanciamento dei poteri), affinché nessuno prevalga sull’altro e commetta abusi sui singoli.
I diritti e le libertà
Sul piano dei diritti e delle libertà, lo Stato liberale si caratterizzava per una concezione garantista, trovando in esso pieno riconoscimento:
— le libertà civili, volte a garantire il singolo dalle ingerenze del potere politico (tra cui libertà di pensiero, religione, espressione, circolazione, domicilio etc.);
— i diritti politici, finalizzati a coinvolgere l’individuo nella vita pubblica (diritto di associazione, riunione, manifestazione etc.). Fondamentale, in tal senso, fu la concessione del diritto di voto alla classe borghese; per quanto si trattasse ancora di un suffragio ristretto (potevano votare solo i cittadini che pagavano le tasse di un certo ammontare), esso consentiva l’elezione dei componenti di almeno una delle assemblee parlamentari (di regola la Camera bassa; il Senato, invece, rimaneva di nomina regia).
Con l’acquisizione dei diritti politici il suddito, prima sottoposto alla volontà assoluta del sovrano, si trasformò in cittadino, partecipando attivamente alla gestione della res publica.
Le libertà economiche
Nell’ambito delle libertà civili affermatesi nello Stato liberale, un ruolo chiave assunsero quelle economiche (soprattutto a favore della borghesia possidente e industrializzata), che ebbero come inevitabile corollario lo sviluppo di una concezione non interventista dello Stato: pur mantenendo come finalità il soddisfacimento degli interessi collettivi, lo Stato liberale si trasformò in mero tutore del pacifico svolgimento della vita socio-economica, evitando interventi pubblici diretti nelle attività dei cittadini. Il ridimensionamento del ruolo dello Stato, dunque, investì tutti i settori della vita pubblica: l’azione statale era ritenuta legittima solo se indiretta, ossia volta a garantire la sicurezza nella politica estera e in quella interna, il rispetto dei diritti e delle libertà, nonché la pace sociale (evitando lo scontro, divenuto poi inevitabile, fra le classi più abbienti e quelle povere).
Partendo da tali presupposti, anche lo Stato liberale ha conosciuto alcune contraddizioni interne: pur garantendo, formalmente, il principio di uguaglianza e i diritti di libertà, ha lasciato che il libero esercizio del potere economico finisse con il causare gravi diseguaglianze sociali. La questione sociale così emersa ha costituito uno dei temi più scottanti, a livello socio-politologico, negli ultimi due secoli.
Hai bisogno di altre spiegazioni semplici di diritto costituzionale? Qui puoi trovare il compendio di diritto costituzionale e la Costituzione italiana esplicata, inoltre sul nostro canale Youtube troverai una serie di consigli su come superare l’esame di diritto costituzionale.



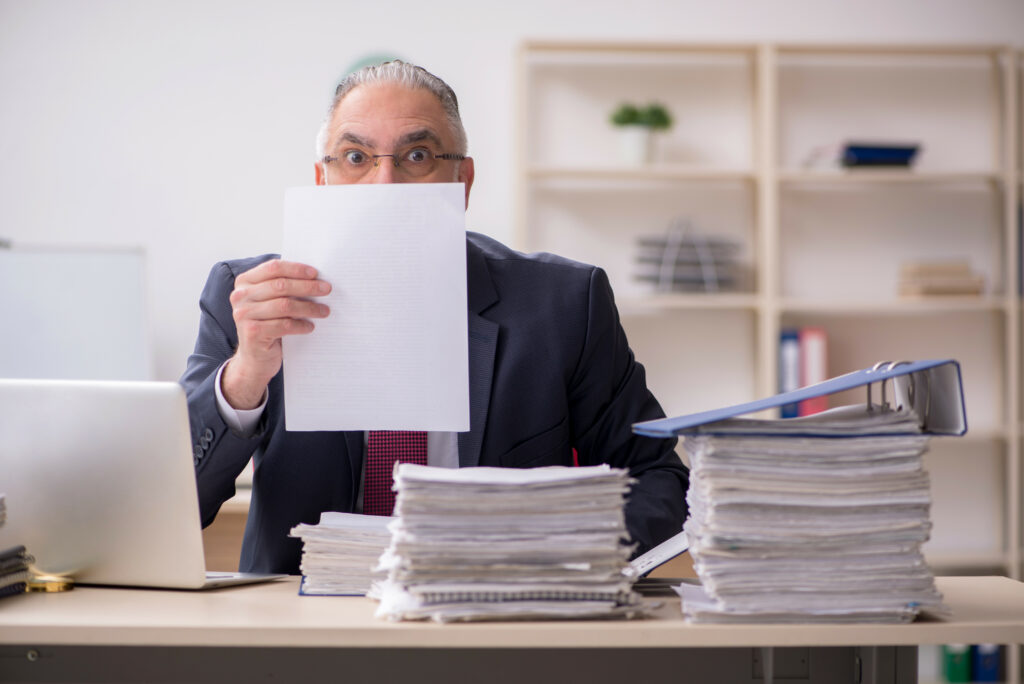







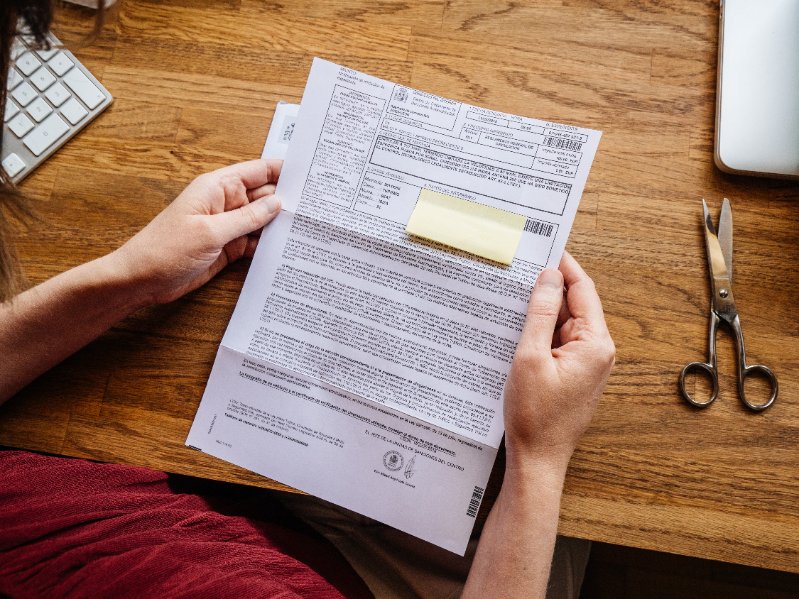








 Concorsi
Concorsi Concorsi scuola
Concorsi scuola Professionisti
Professionisti Università
Università